Rossella Milone è una scrittrice e blogger nata a Napoli ma che vive e lavora a Roma. Ha pubblicato Poche parole, moltissime cose (2013) e La memoria dei vivi (2008) per Einaudi, Nella pancia, sulla schiena, tra le mani (2011) per Laterza e per Avagliano Prendetevi cura delle bambine (2007). Un suo racconto è contenuto nell’antologia L’età della febbre (minimum fax, 2015) che raccoglie alcune delle espressioni più vivaci della narrativa contemporanea. Sempre per minimum fax nel 2015 è uscito il libro di sei racconti Il silenzio del lottatore.
Oltre a diversi premi letterari conquistati e alla collaborazione con alcuni importanti quotidiani e periodici, tra cui un blog di letteratura su IlFattoQuotidiano.it, ha fondato e coordina il progetto Cattedrale, l’osservatorio sul racconto che intende monitorare, promuovere e sostenere la forma letteraria breve. Nell’attività di scrittrice di Rossella Milone sembra avere sempre più peso il racconto. Anche per questo Altri animali le ha rivolto alcune domande sull’ultima raccolta. Il silenzio del lottatore è l’insieme di sei storie che trovano come filo conduttore la capacità dell’autrice di scavare nei meandri dell’introspezione psicologica: sia carezzando sia graffiando quel ventre nudo che è l’individuo; e di farlo col linguaggio della sensualità oppure col cinismo e con la potenza d’amore che contraddistinguono ognuno dei personaggi in gioco. Con una prospettiva da insider la Milone si affaccia con disinvoltura al quotidiano e al singolare, sorvolando e delineando profili caratteriali, sentimenti e modalità relazionali e impugnando sempre saldamente la vena descrittiva e la scorrevolezza narrativa.
La tua scrittura è impregnata di un realismo che sembra nascere da quella che in etnografia viene definita osservazione partecipante, una metodologia di indagine incentrata sulla prolungata permanenza e partecipazione alle attività del gruppo sociale studiato da parte del ricercatore. Se da un lato la forza della narrazione è proprio la prospettiva interna, consapevole e competente, come si riesce a evitare che l’empatia con personaggi e vicende della vita reale surriscaldi la tempra narrativa e bruci quel velo di alterità che rende, in definitiva, una storia assolutamente allettante per i lettori?
È curioso che citi un approccio antropologico per descrivere il mio metodo di scrittura, perché in realtà io provengo da lì; sono un’antropologa e mi sono formata in questo senso. Ovviamente, poiché la scrittura non dà scampo e vede e sa tutto, tutto ciò che riguarda lo scrittore ci finisce dentro, compreso il modo di guardare, compreso il modo in cui si relazione all’altro. E l’altro, in questo caso, per me è la materia narrativa a cui tengo di più. Per rispondere alla tua domanda, credo che lo sguardo dello scrittore debba agire su due piani: uno empatico, partecipativo, inclusivo che gli permette di entrare in contatto con l’umanità che intende raccontare e regalarle un universo emozionale forte e credibile; e l’altro più freddo, distaccato e lucido che permette alla narrazione di non cedere al sentimentalismo e di proteggere quella sorta di alterità di cui parli necessaria alla storia raccontata. Per ottenere questo distacco secondo me il segreto è la distanza. Cioè, la distanza emotiva da ciò che si narra. Più un fatto che vuoi raccontare ti appartiene, ti è vicino e caro, più è necessario distaccarsi nel tempo dall’accaduto. Deve succedere, cioè, come con i ricordi: quando il ricordo è talmente lontano da diventare un po’ qualcos’altro, quando si trasforma, quando acquisisce nuovi connotati e forse non è nemmeno più aderente a ciò che davvero è accaduto. Ecco, quando la materia narrata prende quella sorta di sottomissione rispetto al reale, piegandosi serenamente all’invenzione, quello è il momento giusto per scrivere. Ovviamente questo è il mio metodo; conosco scrittori che, invece, scrivono esattamente al contrario.
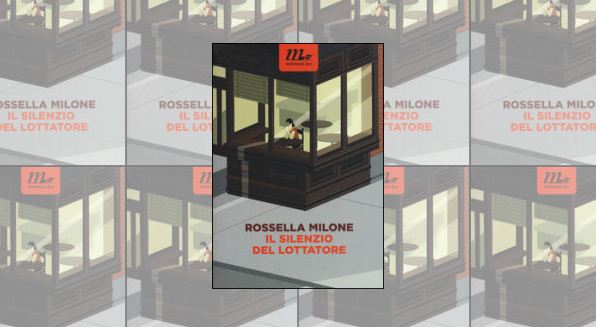
Nella raccolta le tue donne, ammesso che non sia una soltanto, hanno un rapporto particolare col proprio corpo: per un verso questo è simbolo di comando, veicolo del loro potere di controllo sugli altri; per altro verso è il canale attraverso cui introiettano tutto ciò che le getta in sofferenza e il simbolo del loro decadimento. In questo senso qual è il rapporto tra scrittrice e libro e tra corpo della scrittrice e narrazione?
La mia è una scrittura fortemente realistica e sensoriale. In questo senso, la sento molto vicina a ciò che compie il teatro: ti devi mettere addosso certe cose, prima di recitarle, e a me succede un po’ così quando scrivo. Se, per esempio, non mi viene in mente la parola esatta che sto cercando, mi basta mimare il gesto che voglio far fare al personaggio e la parola mi viene. Credo che questo abbia a che fare col fatto che ho praticato sia molta danza che molto teatro, e ovviamente tutto ciò si riversa nella scrittura. Avere consapevolezza del proprio corpo è una faccenda che riguarda tantissime cose, non solo la scrittura. Riguarda il modo in cui ti rapporti col mondo. E il modo in cui ti rapporti col mondo alla fine finisce per costruire il tuo sguardo narrativo, per contaminare le tue storie, per definire che genere di scrittore sei.
Il rapporto di coppia tra uomo e donna può risultare asfittico nelle diverse storie. Non c’è spazio per due corpi e per due spiriti sotto uno stesso tetto o sopra un piccolo soppalco come in Le domande di un uomo?
No, non la vedo affatto così. Sia nella vita, tantomeno in queste storie. Anzi, penso che maschi e femmine sono esseri umani destinati alla convivenza. La lotta se mai sta nel trovare la strada per gestire questa convivenza e gli strumenti per affrontarla con successo. Nelle mie storie i personaggi hanno molte difficoltà con se stessi più che con l’altro; anzi, molto spesso è l’altro che li aiuta a trovare una risoluzione, se c’è. Ne Le domande di un uomo il problema della protagonista non è lui, ma lei: è lei che non sa decidersi perché ha paura. Lo spazio nella relazione è una conquista, ma mai soltanto di uno: è la conquista di due persone che desiderano stare insieme, nonostante tutto.
In alcuni racconti le tue donne superano volontariamente il limite, quasi in un afflato di autodistruzione che però non si compie mai fino in fondo; anche nell’esagerazione, nel continuo spostamento del limite in avanti, non si arriva al gesto estremo. È un tipo di vita tenuta in costante vertigine, ma quel che sembra rivelare è in fin dei conti una cieca solitudine che prevede un partner-mobilio, come arredamento di una stanza vuota nell’animo delle donne in questione?
Oddio, il partner-mobilio è un concetto così lontano da me che trovo difficile avercelo infilato, in qualche modo, nel libro. Piuttosto, quello che accade a questi personaggi è qualcosa di molto comune, e semplice, e forse banale, in cui chiunque può identificarsi: c’è un momento in cui le protagoniste dei racconti si sentono sole, e non dopo aver fatto chissà che. Ma semplicemente perché a un certo punto la vita ha chiesto loro un cambiamento. Io le osservo durante quel cambiamento, con le difficoltà, i tormenti, le inquietudini che questo comporta. Spesso i partner fanno i conti con questi cambiamenti; ne sono vittime, a volte ne sono complici, altre ne rappresentano la causa. È quello che succede alla vita di tutti. Forse in questi racconti a soffrire di più sono gli uomini e questo spiazza un pochino. Però vi assicuro che pure gli uomini, ogni tanto, soffrono per colpa delle donne.
La tua raccolta con l’ultimo racconto che dà il nome al libro, ha un intento liberatorio dopo la catarsi della sofferenza? Vuol essere in qualche modo un premio per i personaggi-martiri della vita e per il lettore che li ha accompagnati durante un raffinato viaggio di introspezione?
Sia la catarsi, sia l’idea del premio presuppongono un ragionamento di tipo aprioristico che quando scrivo non ho. Nel senso che io non mi pongo un obiettivo finale con le mie storie: non mi dico: ok, alla fine farò in modo che ci sia una catarsi liberatoria. Se hai in mente un progetto narrativo, se sai bene qual è la materia che vuoi raccontare e soprattutto se sai seguire i tuoi personaggi – con discrezione e curiosità – alla fine la narrazione ti porta dei frutti che non osavi nemmeno immaginare quando hai iniziato a scrivere. E’ la storia che trova le sue strade risolutive. Lo scrittore deve porsi in una condizione di ascolto e di osservazione, perché tutte le storie nascondono angoli segreti in cui far confluire la sua narrazione.
Qualcuno potrebbe definirti una scrittrice di strada per il modo che hai di rendere in modo fedele alcune situazioni della quotidianità. Questo aspetto traspare particolarmente in Luccicanza, dove il mercato napoletano della Pignasecca diventa lo specchio lercio dell’emotività della protagonista, eppure il teatro della sua abitudinarietà. In questo senso quanto aiuta aver avuto come musa ispiratrice la tua città, Napoli?
Non è una musa. E’ una realtà che conosco molto bene, e quindi ne scrivo. Se lo scrittore scrive di cose che sa e che conosce, allora comincia bene. Napoli è il teatro naturale delle mie storie perché ci sono vissuta. Niente di più banale. E niente di più complicato, anche, perché per raccontare ciò che si conosce molto bene presuppone un forte distacco, molta lucidità e padronanza. Prima, per esempio, non riuscivo a raccontare Napoli. Mi era troppo vicina e ne veniva fuori sempre una cartolina stropicciata. Poi piano piano ho capito quale chiave usare per raccontarla e questo mi ha permesso di offrire a miei personaggi uno sfondo naturale dove vivere.
Cosa ti dà la forma breve del racconto che non trovi nel romanzo?
L’aria. È strano a dirlo, perché il racconto va scritto in apnea, in immersione profonda; mentre col romanzo i tempi dilatati ti permettono un’agilità che il racconto costringe di più. Però è così. Quando scrivo racconti io respiro. Entro in un racconto con tutto il corpo per intero e non ne esco finché non è finito. Mi succede come il pesce che torna in acqua dopo un salto sulla superficie. Quando scrivo racconti mi tuffo, e certe branchie segrete cominciano a farmi respirare in un modo nuovo.




23 Comments