«D’una città non godi le sette o le settantasette meraviglie, ma la risposta che dà a una tua domanda.»
(Italo Calvino)
Cosa significa sentire la propria città che si agita nelle viscere, che plasma il carattere e condiziona i cittadini, i loro usi e costumi, la loro percezione di sé, fino a farli diventare demiurghi e schiavi allo stesso tempo? Cosa vuol dire identità cittadina e come si concilia con le ferite storiche? E come si può dimostrare un sillogismo apodittico – Genova è Genova – mentre «c’è la macaia a ricordarti che sei pur sempre blindato in una città di mare»?
Il tentativo di risposta a queste domande inestricabili come il budello di caruggi nel centro storico genovese, si trova in Genova macaia dello scrittore e giornalista ligure Simone Pieranni, pubblicato nella collana Contromano per Laterza. A quesiti di una risma così spessa e rigida, Pieranni replica con elasticità e con la continua ricerca dello stile. Si tratta di un moto perpetuo verso e lontano dalla verità, fuori e dentro lo stesso registro in una soluzione polifonica, biografica, topografica e storica. Un libro da annoverare tra le scritture ibride perché il genere è difficilmente identificabile in bilico com’è tra memoir, saggio, fiction, autofiction e letteratura di viaggio. Il tu, il noi, la terza persona, ogni strumento e ogni forma sono concessi alla storia soprattutto perché in questo caso la distruzione delle cornici, lo sconfinamento e la variazione dànno un effetto perturbante (proprio come il clima genovese) e incoraggiano alla riscoperta di un mondo da prospettive inattese.
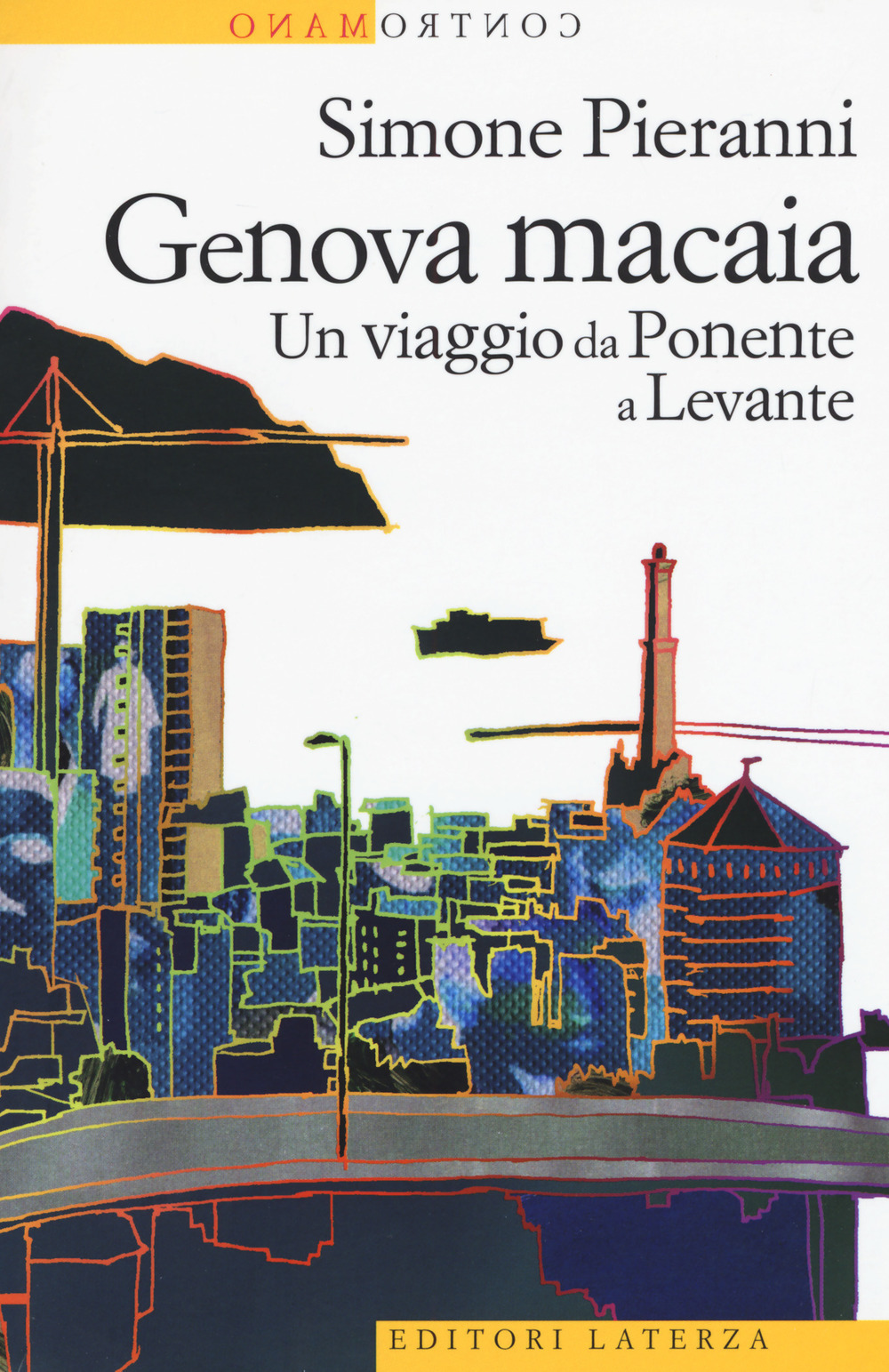
«Una città è come un animale. Possiede un sistema nervoso, una testa, delle spalle e dei piedi. Ogni città differisce da tutte le altre: non ce ne sono due uguali.» Così scriveva John Steinbeck nel 1947 in La Perla e Pieranni sembra in qualche modo ispirarsi allo scrittore statunitense tanto che per cominciare la sua ode personale (ma anche collettiva) alla città amata – nell’accezione del topos catulliano – parte proprio dal sistema nervoso, dalla radice di tutto: la casa natìa. Quel palazzo nel quartiere Bolzaneto, nella striminzita via Bertelli adiacente allo svincolo autostradale, che non esiste più, cancellato dalla toponomastica con l’arrivo del mercato ortofrutticolo. «È strano andare nella propria via e non trovare la casa dove si è vissuto per tanto tempo. Ancora più strano è andare nella propria via e non trovare più la via.» Si parte da qui, da una rimozione forzata dalla memoria per ripercorrere le tappe – da Ponente a Levante, come recita il sottotitolo – dell’evoluzione di una città e della maturazione di un uomo che è prima di tutto un cittadino genovese.
«Bolzaneto negli anni Ottanta sembrava una frontiera, in bilico tra la desolazione e Genova. Una periferia senza alcun fascino, neanche per lo squallore: ricordo persone con i gomiti poggiati sul parapetto del poggiolo, intente a fumare e a riflettere solitudini in pigiama; il marciapiede da un lato, file di macchine parcheggiate sull’altro. Di fronte alle case il muraglione di cemento dell’autostrada: alto, come a difendere una fortezza.» In questa capacità descrittiva e allo stesso tempo documentaristica risiede parte del fascino del libro tra le cui pagine sembrano riecheggiare le parole di Philip O’Ceallaigh in Appunti da un bordello turco quando scrive che «se ti vuoi fare un’idea di come se la passa una città devi andare a vedere i suoi margini. Il centro ti dirà che va tutto bene. La periferia ti dirà il resto».
Quella di Bolzaneto è una periferia distante appena mezz’ora dal centro, anche se il centro rimane soltanto un esercizio di immaginazione e quando se ne ha esperienza diretta vuol dire che si è intrapreso un viaggio. Bolzaneto è un luogo che offre una rampa autostradale come binocolo sull’unico orizzonte possibile – Genova Ovest –, sparuti caseggiati e il besagnino (il fruttivendolo) sulla strada. Un quartiere anonimo, rilevante per una classificazione al ribasso della qualità urbanistica nella migliore delle ipotesi, che improvvisamente si trasforma in tabù, in uno di quei nomi o parole che si fa fatica a masticare come cancro, pedofilia, stupro, genocidio e altre brutture. Si trasforma in un simbolo che fa torcere lo stomaco. La caserma Nino Bixio diventa «La caserma» e poi «Bolzaneto». I fatti del 2001, l’uccisione di Carlo Giuliani, le torture della polizia e la complicità dello Stato, insomma quel G8 maledetto e i processi interminabili e insoddisfacenti. La vita professionale ma anche la vita d’adulto insieme alla nuova immagine di Genova di Simone Pieranni cominciano da qui, dalle vicende posteriori al luglio 2001. Da quando si affievolisce la Genua trasognata e da quando dire «sono di Bolzaneto» provoca nell’interlocutore «un impercettibile movimento delle labbra e degli occhi» come fosse «un lampo nell’animo, un ricordo tagliente […] una ferita comune, un’offesa comune».
Bolzaneto e quindi Genova diventano l’unità di misura del peso della sconfitta e del terrore come confessa un ragazzo a Pieranni: «Genova per me è un incubo: qualunque cosa si faccia, Genova incombe».
Genova è protagonista e comprimaria allo stesso tempo, prima è fulcro della narrazione poi sottofondo, dal racconto delle vie prendono vita voci e figure umane che si stagliano sul panorama metropolitano per poi ritirarsi e incastonarsi – quasi imprigionate – nel blocco urbano. Una matassa di sopraelevate negozi luci fabbriche donne e uomini che non scorda il proprio passato e che Pieranni fa incarnare direttamente dai membri della sua famiglia. Ed è così che la storia si trasforma in un piccolo-grande documentario (o mockumentary?) corredato dall’ottimo speech dell’autore: «Quando Genova è diventata capitale dell’acciaio, io ero nel pieno della mia gioventù: mi sentivo forte, non ero certo intimorita dalla storia, anzi, ero rinvigorita da quello che avevamo scampato, una guerra, belin, e speravo che la vita mi potesse regalare un avanzo di esistenza di cui andare fiera. Mi viene in mente l’acciaio perché io, sarta provetta, mi ritrovai catapultata a pressarlo in fabbrica. Mi ritrovai a distribuire volantini alle 5 del mattino, a interessarmi anche di quello che succedeva intorno, a leggere anche, a scoprire le scrittrici donne! Poi come in fabbrica c’ero entrata, così ne sono uscita, risvegliandomi tra gli scaffali di una latteria. Meno fatica e più noia, diciamo». Quarant’anni di Storia condensati nel racconto della nonna.

Ferriera di Voltri, Genova, 1952. Fonte: «L’Espresso»
Oppure un piccolo particolare, un piccolo affresco della vita di un uomo che ne disvela l’intera esistenza. Il racconto del signor F., il «fratello di mio padre», che si districa tra maghi, trucchetti da imbroglioni e la pentola col sugo di gallinella a cuocere. La scritta luminosa blu a intermittenza dice BAR RISTORANTE e la mente vola a Barcellona e a quando da Genova si poteva ancora fuggire. Qui siamo nella forma breve, e forse nell’autofiction, non conta molto. Ciò che importa è la storia di F., genoano doc, prima cittadino dei caruggi, figlio dei piccoli malaffari e di una vita di stenti, poi uno dei tanti barcelonins e ancora abitante del ponente genovese e cuoco per calciatori.
Perché Genova è mastodontica e multiforme come l’essere umano ed è fatta anche di antiche regole che riaffiorano passeggiando per le anguste vie del centro, di disciplina di quartiere imposta da organizzazioni criminali: dal Dopoguerra agli anni Ottanta, proprio lì, in quel centro storico «straccione e nobile, cauto e spericolato, che negli anni Novanta viene “recuperato”». Il tentativo di riqualificazione è diventato un mantra per i genovesi e ha portato inevitabilmente con sé il processo di gentrificazione, al netto di alcuni locali intelligentemente recuperati. In quelle stesse vie in bilico tra due mondi Pieranni cerca momenti del passato, odori, immagini e quelle piccole cose che filtrano i palazzi slavati e i marciapiedi traballanti restituendo un’aura nostalgica: i negozi di spezie, la migliore focacceria, le bancarelle di libri. D’altra parte «Genova è una partita aperta che chiede un ritorno per disarcionare dal passato quanto è rimasto non detto. Per ritrovare te, i nostri percorsi, le nostre scoperte della città, i nostri discorsi tra i caruggi e sulla macaia, i vicoli del centro storico e tutte le storie così vicine che ho dovuto recuperare piano piano, passo dopo passo, uscita autostradale dopo uscita autostradale. Da Bolzaneto al centro, dal centro allo stadio, dallo stadio a Recco, ed ecco la riviera: balestre territoriali accompagnate dal procedere del tempo, dalla crescita mia, dalla consapevolezza di vivere la città come fosse l’interno di un guanto, sempre lì, avvolgente e all’apparenza conosciuto, ma in realtà invisibile agli occhi».
Sembra, ancora una volta, che la città diventi un gigantesco ammasso antropomorfo e bestiale insieme, un tutt’uno metereopatico sensibile alla macaia e al richiamo del mare. Un mostro, anzi «proprio un drago, maestoso e sempre un po’ preoccupato» e anche «diffidente». E lo sviluppo urbanistico cittadino pare l’uscita dalla pubertà di questo drago millenario, un momento di passaggio che forgia il carattere dei genovesi, che se ne vanno e portano ovunque Genova con sé, da bravi costruttori di torri in tutto il mondo quali sono stati. Istinto di conquista, di apertura che si affianca al ripiegarsi su se stessi dei vicoli che racchiudono e custodiscono. Di fronte a questa ambivalenza che spinge fuori e che richiama dentro nessuno può essere obiettivo. L’unica illusione di farsi un’idea sensata della città è staccarsene. Ed è qui, da lontano, quando il giramondo Pieranni si trova in Cina – perché «non si può mica rimanere a Genova» –, che il distacco si compie e dà forma all’immagine: «Genova da trauma divenne qualcosa da dimenticare. E Genova allora per te si riempiva di vuoti: quella che hai percorso con me, quella che hai percorso da solo. E dalla Cina Genova divenne uno sbiadito ricordo, c’era un’altra vita da organizzare. Un’esistenza nella quale Genova rimaneva una partita aperta, un senso di colpa e di rabbia che vagava, come le anime dei portuali tracimati dal progresso, come l’animo di una città che percepivi con i tuoi stessi sentimenti di frustrazione e incazzatura repressa».
Se bastasse guardare un focus di Super Quark sulle repubbliche marinare o un documentario sulla nascita e lo sviluppo del triangolo industriale o ancora un orrendo servizio delle Iene sulla nuova vita gentrificata del centro storico genovese per comprendere almeno un pezzo della complessità della città della macaia, non saremmo qui a parlare del libro di Simone Pieranni. La sensazione è che la cosa migliore per avere cognizione di una città – e di Genova in particolare –, sia domandarla a chi ci vive o ci ha vissuto, e magari farsela raccontare al bancone di un bar o sui gradini di una chiesa come fosse una storia proteiforme, inesatta, affascinante. Oppure risparmiare tempo e guadagnare qualità leggendo Genova macaia.




เว็บแทงบอล ufabet คือทางเลือกที่เหมาะสมที่สุดของนักพนัน การพนันบอลเป็นการพนันที่สร้างรายได้และสร้างความตื่นเต้นให้กับผู้เล่นได้เป็นอย่างดี แต่ว่าการเลือกเว็บ ที่ใช้ในการแทงบอลที่ดีนั้นเลือกได้ยาก เพราะผลตอบแทนที่ได้จากการ แทงบอล บางครั้งมีมูลค่าที่สูงมาก ซึ่งเว็บแทงบอลออนไลน์ที่นิยมทีสุดเละมาเป็นอันดับ1ในประเทศไทย ณ ปัจจุบัน เว็บแทงบอล ufabet
pg slot เว็บตรง เครดิตฟรี เว็บสล็อตออนไลน์มาแรงอันดับ 1 ในปี 2023 เเนะนำเทคนิค วิธีการทำเงินจากเกมสล็อต ออนไลน์ง่ายๆ ทริคใหม่ ไม่ตกเทรน มีการอัพเดทบทความอย่างต่อเนื่องรับประกันได้กำไรจริง!!ผู้ให้บริการเกมสล็อตออนไลน์ อันดับ 1 ในประเทศไทย เพราะเราคือเว็บตรง ไม่ผ่านเอเยนต์ ไม่มีประวัติการโกง เล่นได้จ่ายจริง เปิดให้บริการมาอย่างยาวนาน เว็บตรง มั่นคง ปลอดภัยพร้อมให้บริการทุกท่าน ด้วยระบบอัตโนมัติ ที่ดีที่สุด ระบบเสถียรที่สุด รวดเร็วทันใจ ทั้ง สมัคร ฝาก ถอน สามารถทำรายการได้ตลอด 24 ชม. slotgxy888 pg slot เว็บตรง