Visto si stampi, il nuovo libro di Gabriele Sabatini, si nasconde fin dall’inizio dietro una docilità illusoria: «Chi ama davvero i libri può avere momenti di grande piacere nel sentire le storie di come alcuni di questi sono nati, sono stati editati, stampati o pubblicati», ci dice la presentazione. Siamo davanti cioè a nove vicende editoriali che gli addetti ai lavori si sono tramandate «in genere sotto forma di voci di corridoio, leggende o pettegolezzi». Chi meglio di Sabatini, allora, potrebbe raccogliere e presentare al pubblico queste chicche: tra il lavoro come editor alla Carocci e quello di redazione per Flanerì, Gabriele Sabatini si smazza con la scrittura degli altri quasi tutti i giorni. Peraltro, a livello materiale, la suggestione viene accresciuta dall’oggetto che acquistando Visto si stampi ci troviamo tra le mani: la casa editrice Italosvevo infatti stampa ancora i libri come si faceva una volta. Il primo contatto che si ha con il volume di Sabatini è attraverso il tagliacarte: bisogna aprirne una a una le pagine, prima di iniziare a leggerlo davvero – quasi che custodisca un segreto.
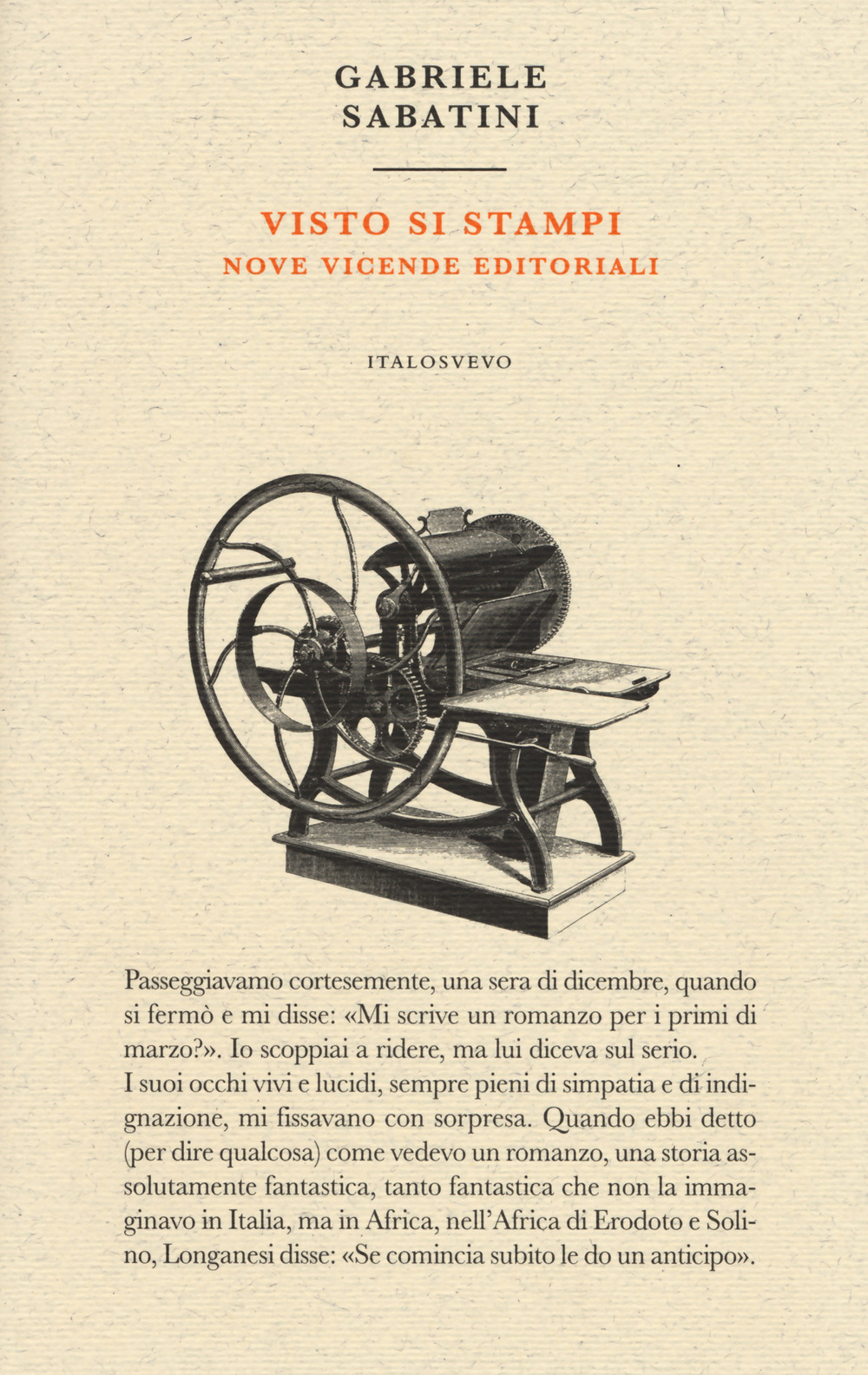
Ma ecco che piano piano ci accorgiamo andando avanti che l’operazione editoriale di Visto si stampi è ben più che una raccolta di vicende gossippare per gli appassionati delle lettere italiane: ogni capitolo infatti racconta di un romanzo, di chi l’ha scritto e di come il libro è arrivato a essere pubblicato, ma Sabatini non sembra affatto scegliere a caso gli autori che ci propone. Ci accorgiamo che esiste una architettura nascosta anzitutto dalla cronologia del volume, che non segue affatto quella delle opere di cui parla. Sabatini sta cercando cioè di raccontarci ben altro: attraverso l’incontro tra il libro (stampato) e la leggenda di come quel dato libro è arrivato alla stampa, si situa una seconda storia – quella italiana. Qui allora cercheremo, per sommi capi, di sciogliere il filo di Gabriele.
Visto si stampi si apre con il romanzo Viva Caporetto! di Kurt Erich Suckert (poi Curzio Malaparte): siamo agli albori del Novecento, lungo il fiume Isonzo. È da qui che Sabatini sceglie di cominciare, perché «la disfatta di Caporetto è uno shock per l’intero esercito e per tutta la nazione; è il crollo del sistema paese». Ma non la pensa così Malaparte, per cui «Caporetto non è una sconfitta, non è un evento passivamente subito, rappresenta […] l’inizio di una sollevazione della fanteria». Già dal primo capitolo, è evidente che l’intreccio è molto più complicato di così: se da un lato infatti Malaparte guarda alla Prima Guerra Mondiale, e anzi a l’episodio particolare di Caporetto, come il (ri)appropriarsi da parte del popolo italiano di una sua identità che la storia pareva avergli rubato, allo stesso tempo la pubblicazione del libro si situa in una situazione che è già post-Caporetto. Mentre Malaparte cerca di interpretare il passato, il presente è preso in ostaggio da una nuova minaccia. Il fascismo non scherza e così la prima edizione di Viva Caporetto! viene sequestrata senza indugi. Benché «Mussolini, sebbene già molto influente, deve ancora prendere il potere», riesce a far sequestrare anche le due edizioni successive, nonostante gli accorgimenti dell’autore.
Siamo effettivamente davanti a una impasse editoriale, che corre parallela a quella reale del paese. E forse non a caso a dominare i tre capitoli successivi è proprio una condizione di stasi: Cronache di poveri amanti (Vallecchi, 1947) di Vasco Pratolini, sebbene sulla prima edizione riporti «Napoli, 3 febbraio 1946 – Firenze, 14 settembre 1946», nasce in realtà dopo un travaglio durato circa dieci anni. Mentre la storia si muove, la scrittura pare fermarsi: durante la guerra, Pratolini è impiegato presso il Ministero dell’educazione nazionale, poi nel 1943 quando Mussolini cade, lo scrittore si unisce alla Resistenza – e avanti così. Insomma, per un motivo o per un altro, Pratolini non riesce a stendere il romanzo. E in qualche modo, anche il luogo del romanzo rappresenta al meglio la condizione di cui sopra: siamo nella Firenze tra le due guerre, in Via del Corno, una strada popolare che ci viene presentata come un palco teatrale. Anche in Il piatto piange (Mondadori, 1962) di Pietro Chiara, la stasi caratterizza ancora il luogo: qui siamo in un piccolissimo paese, nella Luino cioè di anteguerra. Per chi non lo conoscesse, Sabatini ne fornisce addirittura le esatte coordinate: «Luino è un paese incastonato in un angolo d’Italia, cinto a ovest dal lago Maggiore, a nord e a est dalla Svizzera; dista nemmeno quindici minuti di automobile dalla frontiera». È forse Geno Pamploni a cogliere meglio l’idea di base dell’opera: «immagine di una giovinezza culturalmente e spiritualmente disoccupata, nell’aria inerte e opaca del tempo fascista». Precisa ancora Sabatini: «la dittatura è infatti solo uno sfondo verso il quale i protagonisti sembrano nutrire una sostanziale indifferenza». Quindi, di nuovo, impasse, stasi, tanto del luogo, quanto del tempo del romanzo – e, come per Malaparte, anche per il presente di Chiara, che andrà poi esule in Svizzera.
Il terzo romanzo, Tempo di uccidere (Longanesi, 1947) di Ennio Flaiano, è la storia della fanteria italiana in Abissinia nella campagna del 1936. Eppure, è ancora la stasi che sintetizza meglio il tentativo di interpretare la storia, perché l’avventura militaresca in Africa è per Flaiano, che pure era stato (suo malgrado) ufficiale in Etiopia, «un’avventura senza senso». E l’impasse non manca di cogliere nemmeno l’uomo nel suo rapporto con la scrittura: «Dominato da quella pigrizia che è poi rispetto per la letteratura, Flaiano […] ha tardato dieci anni ad affrontare il romanzo […] Tipica opera di pigro, sognata e limata, prima di essere scritta di getto» dirà di lui Umberto De Franciscis. A muoversi pare solo l’editore, così tanto anzi che non riesce neppure a inserire le ultime correzioni dell’autore nella bozza finale, perché ormai già in stampa. Tra i tre autori, è forse però Pratolini che accenna meglio, nell’architettura di Sabatini, a ciò che verrà dopo, perché «tenta di raccontare non più solo le singole vicende ma, attraverso quelle, le sorti di tutta la comunità».
Siamo infatti partiti dalla «rivolta» di Caporetto. Ed è alla collettività che Sabatini vuole ricondurci. Se infatti il capitolo dedicato a Il vecchio con gli stivali (Bompiani, 1946) di Vitaliano Brancati si apre illusoriamente con un passaggio di testimone, cioè con un incontro proprio tra Flaiano e l’autore, siamo tuttavia fermi nell’ambito della rivolta individuale, perché la protesta del romanzo contro i sedimenti del ventennio «non coinvolge gli altri, non fa massa». Persino Valentino Bompiani, a tiratura già avviata, confessa a Brancati di aver terminato di leggere il libro solamente a stampa avviata.
L’abilità di Sabatini sta nel parallelismo: alla rivolta individuale, si oppone finalmente una nuova rivolta collettiva. Alla stasi, si contrappone una nuova stasi. A Caporetto infine, una nuova ritirata. Il sergente della neve (Einaudi, 1953) di Mario Rigoni Stern. L’autore – che autore vero non è, diranno molti: nel senso che non è uno scrittore di professione – si trova prigioniero dei tedeschi, quando nel 1944 ha una intuizione. Decide cioè di trasformare il suo diario in una testimonianza storica… meglio ancora, in un romanzo. Stern aveva ventun anni quando gli arriva l’ordine di condurre la ritirata di settanta alpini, perché «nessun ufficiale sarebbe giunto per occuparsene»: la Russia è troppo forte, non c’è modo di proseguire la campagna. È, quella esperienza, per Stern, il vero capolavoro della sua vita.
Ma a questo punto Sabatini va oltre il parallelismo evidente tra questo capitolo e il primo: alla ritirata, sostituisce il bombardamento, la tabula rasa. Alla testimonianza storica, l’immaginazione. Siamo ancora in una stasi: questa volta, è Giuseppe Berto a essere in una prigione. In particolare, Berno si trova a Hereford, in Texas, prigioniero degli americani. Lì gli arriva la notizia che Treviso è stata bombardata. Allora, «cominciò a scrivere senza la reale cognizione degli accadimenti italiani, sforzandosi di immaginare come sarebbe finita la guerra». Ma qui non conta più l’esatta testimonianza: la letteratura cerca di «allegorizzare» la storia, di comprenderla attraverso le armi che ha, quelle della finzione. Il bombardamento diventa quindi il simbolo per eccellenza della fine di una civiltà, ma anche della possibilità di una rinascita. Il paradosso è evidente all’editore, che tuttavia accoglie il romanzo con entusiasmo: se in redazione tutti paiono stufi dell’ennesimo romanzo sulla guerra e sulla Resistenza, «E invece è un colpo – replicò Longanesi – parli di Resistenza, ma questo giovanotto ha il vantaggio di averla descritta senza avervi mai partecipato, anzi, senza averla nemmeno vista». C’è anche dell’altro: «alla tentazione di lanciare come bardo della Resistenza un ufficiale in camicia nera, non resisto».
Finalmente allora il cerchio può chiudersi: è il momento di La ragazza di Bube (Einaudi, 1960) di Carlo Cassola, vero baluardo della letteratura sulla (e di) Resistenza. Ma Sabatini ci dà un ultimo indizio: l’ultimo capitolo è dedicato infatti non più a un autore, ma a una casa editrice. La storia della Longanesi sembra la metafora di una ricostruzione. Ma che si tratti di una ricostruzione sulle macerie, ce lo suggerisce forse il giallo paglierino della carta che Vittorini aveva comprato a basso prezzo, in un periodo di carenza generale. Come a dire che per chi fosse stato smemorato, quel giallo antico avrebbe rinfrescato la memoria… e non c’era da preoccuparsi per la letteratura, perché di quella carta la Longanesi aveva fatto scorta.




It proved to be Pretty handy to me and I am certain to the numerous commentators suitable listed here! ทางเข้าสล็อต