
1948. Un piccolo studio nel cuore di Manhattan. Sam Zemurray, un omaccione enorme e mal vestito, senza cravatta, con la barba incolta e gli stivali da contadino, si è appena seduto di fronte a un altro signore, quindici anni più giovane di lui, agghindato con un abito elegante, baffo, brillantina e posa aristocratica. Dopo pochi scambi di battute, Edward Bernays, il pubblicitario eccentrico che odorava di colonie Yardley, data la scarsa impressione che gli aveva fatto fino a quel momento quel visitatore trasandato, fa per alzarsi e liquidarlo, ma il suo interlocutore lo ferma. «Vado dritto al sodo. Dirigo una compagnia che importa banane negli Stati Uniti dall’America Centrale, sembra che abbiamo una pessima fama qui e nei Paesi in cui operiamo, e lei può essere la persona giusta per rimediare a questa situazione». Ancora non lo sanno, ma quei due uomini così estremamente dissimili stanno per modificare il corso della storia di un intero continente.

Tempi duri, il nuovo romanzo del Premio Nobel Mario Vargas Llosa – pubblicato in Italia da Einaudi (328 pp., 20 euro) così come tutta l’opera dello scrittore peruviano – si muove tra El Salvador, l’Honduras e il Guatemala a cavallo tra gli anni ‘40 e ‘50 del secolo scorso e racconta come gli interessi statunitensi della United Fruit Company (la futura Chiquita) e le idee di due uomini in particolare, daranno insieme il via agli avvenimenti che nel 1954 porteranno a un colpo di stato appoggiato dalla CIA in Guatemala, in quel braccio di terra tra i due mari in cui el Pulpo, come era nota in gergo l’enorme multinazionale gringa, aveva la base principale dei suoi affari.
Bernays, un personaggio strampalato che si era reso famoso organizzando il tour americano del celebre cantante Caruso, e che tra le altre cose era anche il nipote di Freud, accetta l’incarico. La sua consulenza contribuisce molto nel ripulire l’immagine della compagnia assicurandole sostegno e influenza all’interno del mondo politico. Convince Zemurray, un «imprenditore troglodita che sembrava uscito da un libro di avventure piuttosto che dal mondo industriale statunitense» a sforzarsi di fare almeno un minimo di beneficienza, fosse anche di facciata, costruendo qualche scuola e ospedale da campo per gli abitanti delle sue piantagioni e al contempo, tramite una rigorosa pianificazione, promuove negli Stati Uniti, assieme a scienziati e tecnici, il consumo delle banane a colazione e a tutte le ore del giorno, convincendo del loro apporto indispensabile per la salute e la crescita di cittadini sani e atletici. Sua anche l’idea di portare negli Stati Uniti Carmen Miranda, la formosa cantante brasiliana nota al mondo come la signorina Chiquita banana.
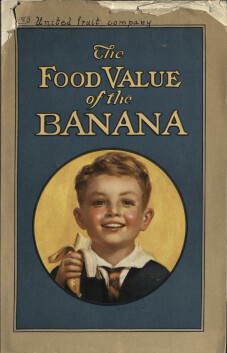
I problemi iniziano sotto il governo Arévalo, che si era permesso “addirittura” di dichiarare legale l’istituzione di sindacati dei lavoratori. Il che fa drizzare le orecchie ai vertici della United, preoccupati della “pericolosa” deriva social-comunista che avrebbero potuto prendere i Paesi in cui la compagnia si trovava ad operare. Durante un concitato consiglio di amministrazione si solleva il problema, e a Bernays viene proposto di occuparsene.
Come prima cosa, da uomo del suo tempo, decide che il modo migliore per avere un quadro generale della situazione è recarsi laggiù. Passa due settimane in Guatemala, non mancando di annotare con pedanteria quanto avesse patito le punture di zanzara e il caldo soffocante. Fa dell’Hotel Panamerican, nel centro storico della città e a pochi passi dal Palazzo del Governo, il suo quartiere generale, dove nel giro di due settimane avvalendosi di interpreti – dato che non parlava una singola parola di spagnolo – incontra dignitari, commercianti, proprietari terrieri, parlamentari, poliziotti, stranieri lì radicati da anni e si fa un’opinione ben precisa: non c’è alcuna minaccia di infiltrazione sovietica nel Paese.

I dettagli sono contenuti nel rapporto che Bernays legge, con dizione da attore consumato, davanti al consiglio di amministrazione al suo rientro. «Il pericolo vero è di altra natura. Il Presidente del Guatemala, il professor Juan José Arévalo è anticomunista tanto quanto voi e me, e non ha mancato di sostenere che “il comunismo è il pericolo maggiore che devono affrontare le democrazie”, ma per quanto possa sembrarvi paradossale, il suo amore smisurato per la democrazia rappresenta una seria minaccia per la United Fruit. Arévalo vorrebbe fare del Guatemala una democrazia come gli Stati Uniti, Paese che ammira e che considera un modello. I sognatori sono spesso pericolosi e in questo senso Arévalo lo è».
Parliamo di un’azienda che era riuscita a costruire le proprie ricchezze sfruttando proprio l’arretratezza degli Stati in cui si trovava a operare, una compagnia che agiva spesso con il collaborazionismo di regimi totalitari in totale assenza di vincoli o regole e in condizione di sostanziale monopolio, senza dover pagare tasse per il proprio operato e soggiogando i suoi lavoratori a una dimensione produttiva alienante e che vedeva la costituzione libera di sindacati come un’eresia impronunciabile.

Parliamo di un secolo in cui quello che accadeva al sud dei tropici aveva ancora un qualche interesse e una qualche risonanza per l’opinione pubblica internazionale. E perciò se si voleva cambiare qualcosa, bisognava farlo con cautela, e usando una strategia ben precisa. Bisognava dirottare l’intera opinione pubblica a credere nell’esistenza di una minaccia, di un fine superiore, malvagio e sbagliato, e in quanto tale da troncare sul nascere, pena conseguenze nefaste per le sorti dell’intera nazione. «Tocca a noi informare il governo e l’opinione pubblica che il Guatemala – uno Stato che la maggioranza delle persone nemmeno sa che esiste – costituisce la testa di ponte per l’infiltrazione sovietica nelle Americhe e dobbiamo farlo in modo da convincerli che il problema è così serio, così grave, da doverlo scongiurare immediatamente».
Anche i giornali liberal caddero nell’inganno, anzi furono scelti come il veicolo principale attraverso il quale convogliare l’informazione, rispetto alla più sospettabile stampa conservatrice. C’era la Guerra fredda, gli USA vedevano l’ex alleato mangiarsi l’Europa a bocconi, avevano sviluppato una vera e propria paranoia della presenza comunista, perciò fecero una follia, credettero a ciò che non c’era.
Solo la realtà si può permettere il lusso di essere inverosimile, e allora nelle pagine compare tutta una costellazione di individui che sembrano prodotti della fantasia, personaggi da romanzo come il temibile colonnello Castillo Armas, di umili origini, con tratti più da indio che da bianco, che dopo essere salito al potere si era subito premunito di creare un indispensabile “comitato nazionale di difesa contro il comunismo”, in un momento in cui è probabile che non vi fosse nemmeno un cittadino sovietico sull’intero suolo guatemalteco, e aveva inaugurato i roghi di libri in strada, roba da far rabbrividire Ray Bradbury. «Sembrava che fosse resuscitata la Colonia, quando l’inquisizione vegliava sull’ortodossia religiosa a ferro e fuoco. Tutte le biblioteche pubbliche e alcune private erano state purgate da manuali marxisti, libri anticattolici e pornografici (nel dubbio erano stati requisiti e bruciati tutti i romanzi in lingua francese)».

Árbenz
Al centro del romanzo è la figura di Jacobo Árbenz, l’esatto opposto di un estremista di sinistra. Partito da un’educazione militaresca, da accademia, aveva incontrato una donna che aveva amato e sposato, Maria Cristina Vilanova, una salvadoregna appartenente alle cosiddette “14 famiglie” dell’aristocrazia locale ma molto progressista che con le sue argomentazioni e le sue frequentazioni intellettuali gli aveva aperto gli occhi su questioni su cui semplicemente nessuno lo aveva mai fatto riflettere prima di allora. Non ne aveva fatto un “pericoloso comunista” come si potrebbe supporre e temere, quanto un pensatore aperto al dialogo, un social-democratico centrista ante-litteram. Vilanova è una figura che è stata spesso comparata a Evita Peron per le sue ferme posizioni femministe e per la forte influenza che ebbero le loro personalità nell’incidere sui cambiamenti dei rispettivi Paesi nel momento in cui i mariti erano al governo.
Quell’ufficiale dell’esercito guatemalteco, partendo da questi presupposti, a poco a poco «era giunto alla conclusione che la chiave del cambiamento, lo strumento indispensabile per avviare la trasformazione della società guatemalteca, fosse la riforma agraria. Bisognava modificare la struttura feudale che regnava nelle campagne». A differenza di molti suoi amici estremisti, Árbenz si opponeva all’espulsione della Frutera dal Guatemala, pretendeva solo che quel Polpo dai mille tentacoli rispettasse alcune semplici regole, come mettersi in regola con il pagamento delle tasse e trattare i lavoratori come degli esseri umani, permettendogli di organizzarsi liberamente in sindacati per far valere i propri diritti, cosa che fino ad allora la compagnia si era premurata di vietare e reprimere.

Eppure le cose vanno molto diversamente, la United riesce, assieme ai suoi sostenitori, a convincere il mondo dell’estremismo di quelle riforme, rendendo la situazione nel Paese talmente frenetica e concitata che nella confusione «girava ogni sorta di voce non verificabile, per esempio che il governo avesse distribuito mitragliatrici tra i proprietari terrieri perché si facessero giustizia da sé nel caso i contadini avessero continuato a occupare le terre della riforma agraria».
La narrazione di Vargas Llosa ci insegna come già in tempi passati le fake news fossero in grado di manipolare il mondo a piacimento di pochi, e a discapito di molti, di ribaltare governi democraticamente eletti per assecondare sotterranei intenti economici.
Azionisti della UFC, la United Fruit Company erano John Foster Dulles, allora Segretario di Stato americano sotto la presidenza Eisenhower, e Allen Welsh Dulles, il fratello, direttore della Cia. Arbenz fu sostituito, in seguito a un colpo di Stato, da Carlos Alberto Armas che divenne Presidente del Guatemala, per poi essere assassinato, in circostanze poco chiare, nel 1957. Vargas Llosa fa di quell’episodio il cardine per un ragionamento più ampio, sulla manipolazione dei documenti, sul tradimento, sui deliri del potere, in una dinamica a lui consueta: quella di usare il romanzo come mezzo di ragionamento politico.
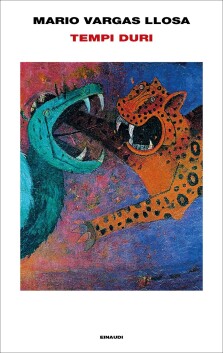
L’uomo davanti alla Storia è sempre l’uomo in mutande, l’uomo nudo, il prodotto dei suoi limiti e dei suoi errori. È questo l’altro insegnamento che Vargas Llosa dà con la sua narrativa, da La città e i cani a Conversazione nella Catedral, da La guerra della fine del mondo a La festa del Caprone: la Storia la fanno gli uomini, i loro vizi e spesso la banalità e l’arbitrarietà di alcune loro scelte. Scelte che fanno di Tempi duri un romanzo storico attuale.
«In due settimane il Guatemala aveva cambiato pelle. Ogni traccia del governo di Jacobo Árbenz sembrava scomparsa e, al suo posto, era sorto un Paese frenetico dove la caccia ai comunisti reali o presunti era l’ossessione nazionale». Mario Vargas Llosa sa bene di dittature e sospensioni della democrazia, poco tempo dopo aver perso la corsa a candidato presidente del proprio paese nel 1990, contro il terribile Alberto Fujimori detto “el chino”, fu costretto a riparare in Spagna, dove lavorava già da anni e di cui ora è cittadino.
Vargas Llosa, nato nel 1936 ad Arequipa in Perù, è stato insignito del Premio Nobel per la Letteratura nel 2010, come si legge nelle motivazioni «per la sua cartografia delle strutture del potere e la sua acuta immagine della resistenza, ribellione e sconfitta dell’individuo». Nei Paesi occidentali non ci sono allo stato attuale regimi come quello peruviano di Odria o di Castillo Armas in Guatemala, ma se osserviamo giorno dopo giorno l’imbarbarimento del discorso pubblico, lo spargimento a macchia d’olio di mezze verità o di informazioni deliberatamente false distribuite per fini precisi, all’arroganza di certi capi di stato che si sentono delle divinità ultraterrene, all’opportunismo di chi non si schiera, alla feroce ostilità verso ogni spinta di rinnovamento, allora molti conti tornano e questa storia può diventare un faro anche per il secolo successivo ai fatti narrati, il nostro.




28 Comments