L’infanzia raccontata da Danilo Kiš in Giardino, cenere (Adelphi, 1986) è un merlettato dispendio di memoria, immaginazione ed energie per acciuffare la morte e lasciarla andare; un gioco portato avanti con la levità di un saltellare bambinesco minacciato dal senso di colpa e dall’abisso. Mancano coordinate storiche e geografiche nette, mancano eventi. Solo due elementi restituiscono il senso di una realtà immaginaria che «conserva la forza del documento»: l’accumulazione di oggetti e sensazioni, e il movimento ondivago tra eros e morte.

Allora per capirci qualcosa bisogna recuperare la sua biografia. Danilo Kiš nacque a Subotica nel febbraio del 1935, il padre era un ebreo ungherese e la madre montenegrina. Kiš trascorse parte dell’infanzia in Ungheria, dove fece esperienza della violenza della guerra e delle persecuzioni contro gli ebrei. Visse nel 1942 i massacri «dei giorni freddi» di Novi Sad. Di questo ambiente balcanico mitteleuropeo, della seconda guerra mondiale vissuta dal padre ebreo, dell’antisemitismo, Kiš restituisce solo gli effetti tangibili impressi sugli oggetti che lo circondavano, sui traslochi, su frasi spezzate colte per caso, sulla trasfigurazione immaginaria della semantica della realtà. Lo sguardo della narrazione è quello del bambino voce narrante, Andreas, che all’inizio coglie il dipanarsi degli accadimenti con una placidità animale. Accoglie e registra l’unica storia alla sua portata, quella frammentata fatta di piccoli oggetti: il profumo di vaniglia e semi di papavero, il vassoio nichelato della madre con le mezzelune lasciate dal fondo dei bicchieri. I tronchi degli ippocastani che sporgono fino a formare una galleria: «Tutta questa architettura appariva salda e immobile nelle audaci costruzioni; soltanto il sole scagliava a tratti i suoi inutili dardi attraverso il denso fogliame. Apertisi un varco in quell’intrico di rami obliqui, essi vibravano un poco per il loro stesso slancio, poi si scioglievano e stillavano sull’acciottolato come argento fuso».
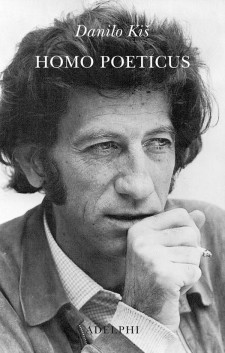
All’inizio del romanzo la descrizione del breve paradiso infantile è dolce e fragile, ha il candore compassionevole di un volto impallidito dalla malattia. Gli oggetti e le sensazioni si stringono, creano l’impalcatura spettrale di un’infanzia. Appaiono sulla pagina con la consapevolezza di dover sparire, un’assenza proiettata già nell’attimo stesso della descrizione. La rincorsa al dettaglio, che si spaccia per accuratezza, in realtà è fuga rocambolesca dalla decomposizione. Non appaiono i muri portanti di questo gironzolare tra i ricordi, non appare la guerra. In compenso c’è la durezza dell’oggetto, del documento microscopico sfuggito alla Storia, la quale invece è senza volto e indifferente. A questa grande Storia muta, senza nome, Kiš contrappone la concretezza della letteratura, a cui è affidato il compito di «correggere la Storia», raccogliendo schegge di vita reale sottratte al corpo morto del tempo dimenticato. In Homo poeticus Danilo Kiš racconta della propria infanzia:
Le prime impressioni della mia infanzia sono legate a Novi Sad, una città che si trova un centinaio di chilometri a sud di Subotica, lungo il Danubio. Odori, sapori, colori. L’odore dei fiori di castagno, delle rose in un vaso, della camomilla, l’odore dell’olio lubrificante nel meccanismo della macchina da cucire, delle sigarette di mio padre, dell’acqua di colonia sul collo di mia madre, della biancheria pulita, dell’urina, della tovaglia di plastica sul tavolo, del caffè, del sapone, degli aromi, del nastro di cuoio all’interno del cappello di mio padre […].”
La narrazione diventa allora una collezione delicata e nervosa di un materiale magmatico partorito dall’incontro tra la memoria e l’immaginazione, che è essa stessa una forma di memoria. È la collezione disperata dei fiori di un giardino paradisiaco, quello dell’infanzia, colto l’attimo prima che avvizzisse falciato dalla morte (la «cenere» del titolo). È quindi un volto ritorto al passato su cui appare la traccia angosciosa del presente. E potrebbe sembrare strano, ma nulla spiegherebbe meglio questa poetica dell’infanzia lontana come le bellissime parole che lo stesso Danilo Kiš rivolge a Nabokov, sempre in Homo Poeticus:
Nabokov scriveva come se guardasse il mondo di lato, in un modo obliquo, spostando l’obiettivo della cinepresa verso la calza pendula di un’ex primadonna, verso il roseo cranio pelato di un importante generale […]. Nabokov concepiva quel paradiso perduto della sua infanzia in modo scolastico, come la caduta degli angeli; in quella caduta, risultato di una macchinazione divina, il ruolo della storia è nullo. Tutta l’opera di Nabokov non è che una proustiana Ricerca del paradiso perduto esploso e frantumato, e le sue farfalle altro non sono che il segno di quell’eterna nostalgia, la sola prova che il paradiso è esistito.”
Ma su questo giardino piomba la scoperta della morte, e lo fa con uno strisciare assassino, con il doppio volto della violenza e dell’eros. La pellicola dell’infanzia, il rullino merlettato di fotogrammi brucia nella camera oscura. Tuttavia il racconto censura gli eventi storici, perché «c’è qualcosa di ripugnante nella sofferenza. Per questo parlo per immagini». E in maniera traslata arrivano i «giorni freddi» della caccia agli ebrei, arrivano i traslochi, le “sparizioni” improvvise, gli sguardi storti del vicinato, il camuffarsi del padre per nascondere il proprio accento, il padre poi morto ad Auschwitz.
Questo padre colto in assenza anche nel pieno dell’azione, Eduard Sam, ispettore delle ferrovie a riposo, ma in realtà trickster decaduto. Il padre autore di un Orario delle comunicazioni tranviarie, navali, ferroviarie e aeree, l’opera interminabile ed enciclopedica rimaneggiata fino all’usura dal nevrastenico. Questo padre rivestito con bombetta e redingote consunte, autoproclamatosi profeta e vittima sacrificale, una figura mitologica bifronte, metà eroe e metà pagliaccio. Un padre colto come in una specie di negativo, nell’immagine della sua assenza. Rappresentato sempre in partenza o in arrivo, in un andirivieni che lascia impronte vuote su cui si adagia l’immaginazione dell’autore. «Ed eccolo, mio padre, seduto nel carro accanto a una giovane zingara dalle poppe rigonfie, maestoso come il principe del Galles o, se volete, come un croupier o come un maître d’hotel (come un illusionista, come un impresario di circo, come un domatore di leoni, come una spia, come un antropologo, come un maggiordomo […]». Un padre la cui assenza diventa motivo di invenzione, vessillo narrativo. Danilo Kiš disse nel corso di un’intervista: «Il padre che appare nei miei libri con il nome di Eduard Sam o E.S. è una proiezione idealizzata a cui non dà fastidio la massa solida, omogenea della realtà e dei ricordi. Per questo il padre è un personaggio doppiamente negativo, negativo per la sua assenza e negativo in quanto eroe letterario. Egli è malato, nevrastenico, alcolista, è un ebreo, in una parola il personaggio ideale per la letteratura».
Di tutto questo, della storia, del padre, dei trasferimenti, lo sguardo infantile di Andreas, la voce narrante, coglie frammenti nevrotici sublimati in una fantasticheria mortifera.
È, ripeto, la vera fine: di me, del mio libro (non posso leggere oltre) e di questo capitolo della Bibbia. La morte arriva del tutto inattesa, interrompe la mia lettura, recide il filo della mia fantasia con le forbici dell’oscurità, e questa oscurità, questa tenebra spaventosa si trasmette alla espressività geniale del testo e dello stile, all’eccitazione nevrotica del corsivo, i cui caratteri cadono come un grido nella inflessibilità professorale del corpo minore, balzano fuori dall’ordine consueto, si spezzano in una sorta di febbre interna, ardono ribelli e anarchici, pronti alle esagerazioni e agli eccessi […].”
La morte irrompe con la violenza di un trauma infantile, non con la pesantezza di una grande impalcatura storica. Kiš dice di un momento molto drammatico della sua infanzia: «In quel momento non sapevo che giorno fosse, né che anno o che secolo. Il mio era il tremito di un cucciolo. Per questo preferisco parlare per immagini». E con la rapidità di un cervello schizofrenico la spensieratezza dell’infanzia si trasforma in incubo notturno, nel terrore che la morte salga dai bordi del letto, nell’insonnia per evitare «l’improvvisa caduta della seta nera», nel tentativo di cogliere la morte di sorpresa uscendo dal dormiveglia. La tragedia in Danilo Kiš non è mai pubblica e globale; è sempre privata e intrinseca, nascosta tra le pieghe delle cose. Non è pubblica, ma è universale. È una condizione metafisica: la realtà poggia sul fondo cupo del nulla, e se ci si sporge troppo è possibile scorgerlo.
E la morte si annida dietro la violenza così come dietro l’eros. Sintomatica la prima esperienza sessuale di Andreas ragazzino: il candore di Julija, rincorsa in un lungo corteggiamento che mischia nascondino e caccia animalesca, le mutandine rosa sfilate tra i campi al sole, sul fieno, le trecce del colore della segale, poi il trasferimento dell’avventura nelle regioni dell’etere, il «vecchio canuto» con «corna da fauno», il suo arrivo accompagnato da lampi, il «Mea culpa» urlato da Andreas. «Immerso in quella vegetazione rigogliosa, con il gusto dell’acetosa sulla lingua, con alghe di bava agli angoli delle labbra, sentii all’improvviso germogliare nei miei fianchi un’estasi malsana; era la stessa sensazione che suscitavano in me la pelle lentigginosa di Julija, il triangolo della sua nuca sotto le trecce, l’odore delle sue ascelle».
Il ricordo di Danilo Kiš in Giardino, cenere diventa allora un vortice di fotogrammi che travolgono la percezione slogata del bambino, originati da due forze motrici: amore e morte.
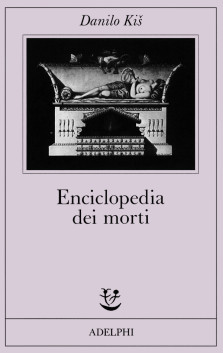
Si arriva quindi a un altro elemento del libro. Da un lato l’accumulazione di immagini, dall’altro il movimento ondivago con cui queste immagini si susseguono. Tutta la narrazione sembra un pendolo disturbante che oscilla tra due poli di attrazione, l’eros e il thanatos. Ma l’eros è solo un’altra faccia della morte. Sotto la crosta della prosa fermenta il movimento tettonico dell’eterno, l’essenza metafisica radice di tutto. Non sono casuali queste parole di Kiš pronunciate durante un’intervista: «Esistono due grandi appigli metafisici, l’amore e la morte, che sono la sostanza della nostra esistenza, e la letteratura ci aiuta solo a esserne consapevoli».
Così come non è un caso che Kiš apra la raccolta di racconti Enciclopedia dei morti con un incipit di Bataille: «Ma rage d’aimer donne sur la mort / comme une fenêtre sur la court». Secondo Bataille l’eros è un modo per sperimentare la morte della propria individualità. Nell’eros l’intensità del godimento che percorre l’individualità ne produce la dissoluzione. Proprio nell’attimo del piacere massimo il godimento sottrae l’individuo all’ordine del tempo, per restituirlo al tempo astorico della totalità. A quel punto l’individuo non è più guidato dall’economia del proprio desiderio, ma da una naturale tensione verso la totalità, per la quale l’individuo prova costantemente una sottesa nostalgia. Ma perché questo avvenga è necessario un atto di omicidio-suicidio metaforico: se l’altro diventa la porta di accesso alla totalità, sarà allora necessario attraversare quella porta tramite l’eliminazione dell’individualità. La propria e quella dell’altro. Un omicidio e un suicidio combinati nel segno dell’amore. In questo senso, scrive Bataille: «L’amore è l’approvazione della vita fin dentro la morte». L’amore è l’anticipazione della morte in seno alla vita. Per questo il susseguirsi di giardino e cenere, di eros e morte, per questo subito dopo l’unione con Julija sopraggiunge il vecchio canuto, per questo subito dopo il bacio proustiano della buonanotte il letto viene aggredito dalla morte strisciante.
In tal senso, quella di Danilo Kiš è una narrazione consapevole che grazie alla letteratura trova il coraggio di scoperchiare la semantica dell’esistenza, ma è anche una narrazione tanto umana. Si sporge sulla ferita ma ha paura di toccarla. Il continuo pendolo tra i due poli è un disperato tentativo di preservare l’individualità del soggetto, un tentativo che sfocia inevitabilmente verso la fine. Il movimento impedisce di attingere in modo definitivo all’eros o al thanatos, che sono due strade dirette al cuore della morte. Quando questo accade, quando Andreas guarda in faccia la «seta nera», una cesura narrativa fa ripartire il racconto dal silenzio della fine, per dar vita a un nuovo girovagare. Così tutta la prosa di Giardino, cenere ha la disperazione di un piacere e di un dolore portati fin sulla soglia del nulla, ma mai troppo oltre, affinché la narrazione possa andare avanti. È una fatica immensa, quella di indugiare sul collasso. Così Kiš abbandona il paradiso imbalsamato di Nabokov, abbandona la nostalgia di una realtà rarefatta e ideale. Kiš scende sulla terra e mischia le carte.
Anche in questo caso potrebbe tornare utile citare il Kiš critico, questa volta a proposito di De Sade:
La lussuria di De Sade pesa come una schiavitù, dolorosa e spossante, monomaniacale e ripetitiva, malgrado la mostruosa fantasia con la quale, in una convulsione estatica, egli fa accoppiare le persone. Nel mondo di De Sade Eros e Thanatos si abbandonano alla lotta, si geme e si rantola, il sangue e lo sperma sprizzano fuori allo stesso modo. Tutto è mortalmente serio, un duro lavoro. L’unica parola umana articolata, quella strappata al petto del torturatore-sibarita è: «Io muoio». E questa parola non è solo una metafora (metonimia) della voluttà al suo acme, ma anche un sostituto della voluttà: vivere l’orgasmo significa morire, giacché l’orgasmo è un orologio biologico che segna l’ora esatta, ogni orgasmo è una piccola morte, finire significa un po’ morire, come si dice: «Partire è un po’ morire».”
Kiš lascia l’irreale nostalgia di Nabokov per sollevare il velo di pizzo sotto cui era stata nascosta la morte. E approda a una nuova dimensione del reale, molto simile a quella di De Sade, in cui «Eros e Thanatos si abbandonano alla lotta». Ma dalla lotta di Kiš non sprizzano sperma e sangue, come nella lotta di De Sade. È una lotta tutta mentale, quella di Andreas, è una lotta che non ha il puzzo degli umori, ma che ha la tragicità di una condizione metafisica ineludibile. La lotta si svolge nella mente del bambino, nella sua distorsione allucinatoria della realtà. Ma proprio per questo mantiene il candore e la timidezza di un atto voluto, capace di ritirarsi al momento giusto per non annientarsi. È un girovagare audace e spaventato. Ha la levità dell’erotismo, non pesa come la pornografia dolorosa e spossante di De Sade. Questo perché sperma e sangue non sprizzano allo stesso modo, nello stesso momento, non si mischiano nella stessa sostanza melmosa della realtà. Sono piuttosto vibrazioni che si riecheggiano a vicenda, si rispondono in una continua fuga dell’istante identico a se stesso. Così il movimento ondivago salva la narrazione di Kiš da un’ossessione monomaniacale per rintanarsi in un vagheggiamento che è coraggio e fuga, un continuo orgasmo castrato, una continua morte scampata. Perché «vivere l’orgasmo significa morire, finire significa un po’ morire».




27 Comments