Mary Flannery O’Connor nasce a Savannah (Georgia) nel 1925 da genitori cattolici di origine irlandese e trascorre la maggior parte della sua vita in una cittadina del Sud degli Stati Uniti. La crescita di O’Connor, considerata una delle scrittrici di maggior culto della letteratura americana, è influenzata dalla morte prematura del padre a causa di un rarissimo lupus, malattia ereditaria di cui lei stessa morirà poco prima dei quarant’anni. La lunga e dolorosa infermità, oltre all’ortodossia cattolica, saranno elementi determinanti nei suoi scritti a partire dalle prime due raccolte di racconti: A Good Man Is Hard To Find e Everything That Rises Must Converge confluite in La vita che salvi può essere la tua (Einaudi per la traduzione di Ida Omboni). Oltre ai due romanzi (La saggezza nel sangue per Garzanti, con la traduzione di Marcella Bonsanti, e Il cielo è dei violenti, Einaudi, traduzione di Ida Omboni) è possibile gustare la raccolta Tutti i racconti tradotta in Italia per Bompiani da Ida Omboni e Marisa Caramella (che ne è anche curatrice).

Il filo comune che lega i diversi racconti di Flannery O’Connor è la volontà costante di presentare al lettore personaggi con i quali è certamente possibile identificarsi, ma solo mettendo da parte un’istintiva repulsione iniziale. È necessario accantonare ogni velleità di appagamento personale o istantaneo e lasciarsi sopraffare gradualmente dalla caratterizzazione dei personaggi e dal ritmo della scrittura. La complessità della lettura non è dettata dal modo di scrivere, ma dal fatto che un lettore assuefatto a scritture confortanti e a scrittori accondiscendenti tenterà a tutti i costi di resistere ai modi brutali e diretti della penna di O’Connor. La singolarità dello stile dell’autrice infatti risiede nell’abbondanza di simboli e metafore che rappresentano sempre una realtà crudele e immediata.
Tutta la forza caustica della scrittrice abbinata alla profonda fede cattolica si può fotografare citando un estratto di The Habit of Being, una raccolta di lettere scritte a partire dal 1955 (pubblicata da Vintage Books nel 1980) che O’Connor scrive alla sua amica di corrispondenza A.:
«Una volta, cinque o sei anni fa, sono stata invitata a cena da amici insieme a Mary McCarthy e a suo marito, Mr Broadwater. […] Lei ha lasciato la Chiesa all’età di quindici anni, ed è una Grande Intellettuale. Siamo arrivati alle otto, e all’una io non avevo ancora aperto bocca una sola volta, dato che non c’era niente che io potessi dire, in tale compagnia. […] La mia presenza era come quella di un cane addestrato a dire qualche parola che le avesse improvvisamente dimenticate tutte, sopraffatto da un senso di inadeguatezza. Be’, verso le ore piccole, la conversazione si è spostata sull’Eucarestia, che io, la cattolica del gruppo, avrei dovuto ovviamente difendere. Mrs Broadwater ha detto che da bambina, quando riceveva l’Ostia, la identificava con lo Spirito Santo, “la più portabile” tra le persone della Trinità; ora la considerava un simbolo, un simbolo piuttosto efficace, in realtà. Allora io ho detto, con la voce scossa da un forte tremito: “Be’, se è un simbolo, che vada all’inferno, allora”».
Questo passaggio è esemplificativo dell’originalità del pensiero che fa da fondamenta alla letteratura di Flannery O’Connor e la sua rielaborazione del binomio, per lei indissolubile, letteratura-religione. Prima di tutto la persona, la scrittrice intellettuale, e insieme la cattolica ortodossa non accetta che un dogma possa essere stigmatizzato e trasformato in cerimonia folcloristica o semplice simbolo. Tuttavia la modalità espressiva di questa convinzione si pone al limite con la bestemmia («se è un simbolo, che vada all’inferno, allora»), atteggiamento che esce ampiamente dai canoni di accettazione dell’etica cattolica. Ciò avviene proprio in virtù della singolarissima sintesi che O’Connor opera tra i due poli di cui sopra.
«Scrivo come scrivo perché sono (non sebbene sia) cattolica. È un fatto, tanto vale dirlo a chiare lettere» scrive nel 1955 in una lettera per A., aggiungendo in un’altra lettera del 1958, «tutti i miei racconti parlano dell’azione della Grazia.»
Letteratura e religione convivono in lei sprigionando una risposta disorientante, soprattutto per quel lettore, già noto, che si aspetterebbe una risoluzione conciliante. Questi elementi animano in vari modi ognuno dei racconti dell’autrice statunitense e producono in ogni storia lo stesso imprevedibile e spiazzante epilogo.
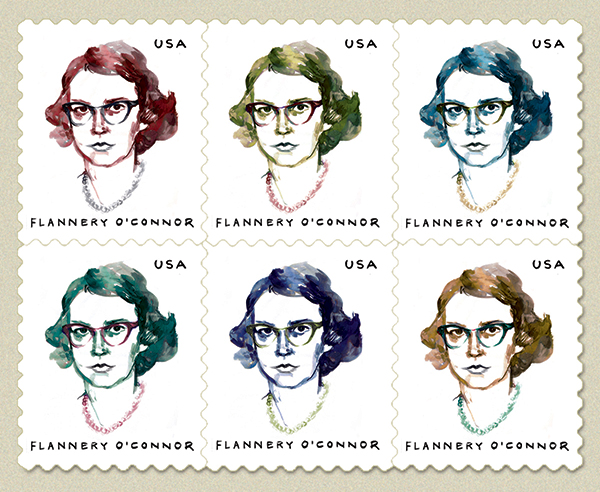
È un gioco lacerante in cui i personaggi incarnano continuamente questa sintesi. Si mostrano come grotteschi burattini alle prese con orribili vicende dettate da un’ineluttabile Provvidenza divina: le calamità naturali, le malattie, i comportamenti feroci e irrazionali degli uomini; a questi eventi i suoi personaggi reagiscono con rabbia cieca, tentano di negare quella che per O’Connor è l’evidenza dell’intervento divino ma alla fine, sfiancati, se ne lasciano ammaliare e trovano nel mistero del sovrumano il senso della vita: una fonte di consapevolezza inesauribile e non negoziabile. In fin dei conti lo stesso destino sembrerebbe toccare al lettore dei suoi racconti: prima irritato dalla superficialità dei protagonisti, poi spaventato dal loro cinismo di fronte alla crudezza degli eventi e in fin dei conti profondamente ammirato dagli esiti imponderabili o quantomeno affascinato dall’inafferrabilità del mistero in cui tutto si risolve.
L’autrice, infatti, aspetta al varco non solo chi legge, ma anche il suo personaggio. I due sono destinati allo stesso modo a non vedere realizzate le rispettive certezze e aspettative, perché l’irruenza della Grazia divina arriva puntualmente a spazzar via tutto.
È in questo modo, per riprendere le riflessioni di Marisa Caramella che cura l’introduzione del volume Bompiani, che ogni storia di O’Connor «scuote, fa a pezzi, il lettore razionale». «Perché [di uomini e] di donne cieche e presuntuose, di intellettuali ironiche e grintose che si trovano improvvisamente a fare i conti con il mistero, la raccolta è piena.»
In questo commento si ritrovano alcune tracce per leggere la dura critica che O’Connor muove alla società in cui ha vissuto e in modo particolare ai cosiddetti interleckchuls (intellettualoidi). Ciò che osteggia è quel «buon senso» vagamente laico, razionale e illuministico degli intellettuali. Esempio lampante di questa accusa è il racconto Gli storpi entreranno per primi: il protagonista, Sheppard, è volontario presso il riformatorio della sua cittadina nel Sud degli Stati Uniti. È vedovo, progressista, filantropo e ha un figlio, Norton, che giudica fondamentalmente viziato ed egoista. Così decide di accogliere in casa un giovanissimo delinquente storpio che vorrebbe redimere attraverso un’educazione laica capace di sviluppare l’intelligenza. In realtà il nuovo ospite non farà che ribellarsi e sobillare il figlio Norton, il quale più che viziato è ancora incapace di metabolizzare la morte prematura della madre. Sheppard scoprirà presto dal fallimento dell’operazione di aver «rimpinzato il suo vuoto di opere buone come un ingordo» e di aver soltanto tentato di accrescere il proprio ego che adesso rimane del tutto sgonfio. L’epilogo, in pieno stile O’Connor, è tragico e imprevedibile: Norton si suicida e Sheppard rimane imprigionato nella consapevolezza di aver travisato tutto e non aver saputo riconoscere il dolore del figlio.
E ancora una volta il caleidoscopio dell’autrice ricompone in un’unica immagine letteratura e religione laddove scrivere e credere sono allo stesso modo un walking in darkness. Da queste premesse scaturisce l’analisi sferzante dell’umanità che popola gli Stati Uniti tra gli anni venti e cinquanta del Novecento e che non risparmia certo la comunità cattolica; anzi è proprio nel ventre del fedele medio che affonda il bisturi critico, come si evince da questo estratto citato Nel territorio del diavolo (raccolta di saggi di O’Connor tradotta da Ottavio Fatica per minimum fax, titolo originale: Mistery and Manners):
«Se si arrivasse a snidare il lettore cattolico medio attraverso le paludi di “lettere al direttore” e altri luoghi dove esce per un attimo allo scoperto, ci si accorgerebbe che è più manicheo di quanto la Chiesa non gli permetta. Separando quanto più è possibile natura e grazia, ha ridotto la sua concezione del soprannaturale ad un pio cliché e ormai è capace di riconoscere la natura della letteratura in due sole forme: il sentimentale e l’osceno».

O’Connor è la scrittrice che ha ispirato e ammaliato tra gli altri Bishop, Barthelme, Carver fino ai nuovi talenti della letteratura americana; un’autrice che ha tratto ispirazione dal suo «caro vecchio lurido Sud», fucina di grandi Southerners come Faulkner o Capote; una scrittrice che affonda le proprie radici nel cattolicesimo proprio lì, in uno dei feudi della Bible Belt protestante dove la Chiesa di Roma è una minoranza; in una cittadella come Milledgeville che oggi conta poco meno di ventimila abitanti e che fu capitale della Georgia dal 1804 al 1868. Un luogo che incarna in modo esemplare la struttura e la meccanica di una società, quella a sud degli States per l’appunto, troppo complessa per essere ridotta a covo di bifolchi e bigotti integralisti religiosi.
«Tutto ciò che proviene dal Sud verrà chiamato grottesco dal lettore del Nord, tranne nel caso in cui sia davvero grottesco, e allora sarà chiamato realistico.»
La lente di ingrandimento di O’Connor in questo senso è privilegiata. Gran parte della sua esistenza la passò studiando, scrivendo, allevando gli animali della sua fattoria, soprattutto pavoni e polli che amava dipingere, e tenendo conferenze tutte le volte che riusciva a viaggiare, nonostante la gravità della sua malattia. Ma soprattutto spese il suo tempo a osservare la propria comunità con occhio vigile e acuminato, riproducendo con dovizia di particolari e sfumature, tra le altre, la narrazione del country come to town.
In Il negro artificiale, per esempio, si può cogliere lo sguardo di O’Connor sempre in equilibrio pericolante tra gli aspetti ridicoli, al limite del tragicomico dei suoi personaggi e la registrazione glaciale di quell’universo sudista che le gravita attorno; una società che sembrerebbe avere tutti i crismi dell’arretratezza culturale ma che l’autrice sveste dagli abiti facilmente rilevabili dell’apparenza per abbigliarla di realismo e misticismo.
«D’un tratto, l’espressione serafica del signor Head cambiò. Chiuse la bocca quasi del tutto e negli occhi gli brillò una luce aggressiva e circospetta. Stava guardando verso il fondo del vagone. Senza voltarsi, prese Nelson per un braccio, e gli diede uno strattone in avanti. “Guarda”, ordinò.
Un uomo enorme, color caffè, avanzava lentamente verso di loro. Portava un completo chiaro e una cravatta di raso giallo con una spilla di rubini. Una mano posava sul ventre, che sporgeva maestoso dentro la giacca abbottonata, nell’altra stringeva il pomo di un bastone da passeggio nero […] Dietro di lui venivano due ragazza color caffè, una vestita di giallo e una di verde. […] Il gruppo percorse il resto del corridoio e uscì dal vagone. La stretta sul braccio di Nelson si allentò. “Cos’era quello?” domandò il signor Head.
“Un uomo” rispose il bambino, con uno sguardo sdegnato come se fosse estremamente stanco di sentir insultare la propria intelligenza.
“Che specie di uomo?” insisté il signor Head, con voce incolore.
“Un uomo grasso” precisò Nelson. Cominciava a sospettare che gli convenisse andar cauto.
“Non sai di che specie?” domandò il signor Head, in tono decisivo.
“Un vecchio” disse il bambino, ed ebbe l’improvviso presentimento che la giornata non sarebbe stata piacevole, per lui.
“Quello era un negro” annunciò il signor Head, appoggiandosi allo schienale.
[…] “Tu hai detto che erano neri” protestò con voce rabbiosa.
“Non mi hai detto che erano abbronzati. Come vuoi che sappia le cose, se non me la conti giusta?”
“Tu sei ignorante, ecco tutto” sentenziò il signor Head […].»
In questo racconto il signor Head ha deciso di portare il nipote Nelson a visitare la città perché il bambino ne conosca la depravazione e decida che la fattoria di proprietà è il luogo migliore dove vivere. Appena scesi dal treno, dopo l’episodio citato, il signor Head si perde nei meandri di quartieri tutti uguali per decine di isolati, sebbene ostenti grandi capacità di orientamento al nipote, il quale è sempre più stanco per la lunga camminata cittadina e come al solito impertinente. È così che decidono di fermarsi per riposare; il bambino si addormenta e il nonno, per dargli una lezione e dimostrare la propria superiorità in quanto a conoscenza del mondo, si apparta in un angolo in modo che quando Nelson riapra gli occhi si ritrovi da solo nella spaventosa distesa urbana; il signor Head immagina che senza dubbio il nipote a quel punto sarà costretto a riconoscere la necessità del nonno, che la sua arroganza di bambino polemico non vuole ammettere. Tuttavia, al risveglio, il bambino è così terrorizzato da scappare come un fulmine in direzione casuale senza che il signor Head possa raggiungerlo ed evitare che Nelson vada a sbattere contro una signora di passaggio, rompendole una caviglia. Il nonno giunge al capannello che si è formato, composto da donne infuriate che reclamano la presenza del padre del bimbo a cui la faranno di certo pagare; ma il signor Head, incalzato dal manipolo petulante e da un ipotetico intervento delle forze dell’ordine, decide di rinnegare la parentela con Nelson: «Non l’ho mai visto prima» dice, raccogliendo lo sguardo di ribrezzo delle donne presenti e quello mortificato del bambino.
A ciò segue la profonda indignazione di Nelson e lo sconforto del nonno che si rende conto che nulla più in quel rapporto, e nella sua vita, tornerà com’era stato: «Sapeva di vagare in un luogo nero e sconosciuto, dove nulla era più come prima, verso una lunga vecchiaia senza rispetto e una fine che sarebbe stata la benvenuta, perché era la fine».
Ma ecco che O’Connor regala una svolta che completa la scena di quel realismo e insieme misticismo di cui si parlava:
«Non aveva percorso mezzo miglio, quando si trovò, a portata di mano, la statua di gesso di un negro, seduto su un muro di mattoni che girava attorno a un ampio giardino. […] Il signor Head rimase a fissarlo in silenzio, finché Nelson venne a fermarsi a pochi passi da lui. Poi, mentre se ne stavano lì, tutt’e due, immobili, esclamò, col fiato corto: “Un negro artificiale!” […] “Un negro artificiale” ripeté Nelson, esattamente nello stesso tono del signor Head. […] E rimasero fermi, allungando il collo quasi allo stesso angolo, con le spalle curve quasi nella stessa posizione e con le mani che tremavano, in tasca, nello stesso modo preciso. […] Fissavano il negro artificiale come se si trovassero di fronte a un grande mistero, un monumento alla vittoria altrui che li riuniva nella comune sconfitta. Tutt’e due sentirono le loro differenze dissolversi in un atto di pietà. Il signor Head non aveva mai conosciuto la pietà, perché era stato troppo buono per meritarla, ma in quel momento seppe di averla incontrata. Guardò Nelson e capì di dover dire qualcosa per dimostrargli che era ancora saggio, e nello sguardo che il bambino gli ricambiò lesse il bisogno famelico di venire rassicurato. Pareva che gli occhi di Nelson l’implorassero di spiegare, una volta per tutte, il mistero dell’esistenza.
Il signor Head schiuse le labbra per fare un nobile pronunciamento e sentì la propria voce dire: “Non ne hanno abbastanza di negri qui. Ne vogliono anche uno artificiale”. Dopo un attimo, il bambino annuì, con uno strano brivido attorno alla bocca, e disse: “Andiamo a casa, prima di perderci ancora”».
In questo modo O’Connor riempie i suoi personaggi di una materia grezza che attinge dall’asprezza della realtà e, allo stesso tempo, li fa risplendere di una luce che ne dilata sguardo e pupille come quando gli occhi, al buio, sono costretti a sforzarsi per far entrare quel po’ di luce disponibile; e ciò anche, e soprattutto, di fronte alla loro lapalissiana grossolanità. L’autrice infatti è alla continua ricerca del crossroads, un incrocio, il punto di contatto dove terreno e divino si incontrino.

«Credo che uno scrittore serio descriva l’azione solo per svelare un mistero. Naturalmente, può essere che lo riveli a se stesso, oltre che al suo pubblico. E può anche essere che non riesca a rivelarlo nemmeno a se stesso, ma credo che non possa fare a meno di sentirne la presenza.»




pg slot thเป็นเกมออนไลน์ ที่เกมบันเทิงใจยอดเยี่ยม เล่นแล้วได้จริง เครดิตฟรี 50 เล่นแล้วร่ำรวยทำให้คุณมั่งคั่งขึ้นได้ PG SLOT แค่เพียงคุณร่วมบันเทิงใจกับ สล็อต ต่างๆที่มีให้เล่น ทดลอง เล่น ฟรี ได้แล้ววันนี้