Fra i tanti aforismi di Flaiano ce n’è uno in particolare che mi ha sempre fatto ridere. Diceva del famoso pittore: «Mondrian, pittore realista». Ovviamente Flaiano era serissimo. La sua non voleva essere una parodia di Mondrian, o almeno non più di quanto, secondo il suo punto di vista, i quadri del pittore intendessero parodiare l’Olanda. Per Flaiano infatti non c’è caricatura in quella celebre serie geometrica, nessuna distorsione della realtà. A fianco del pittore predicava piuttosto l’esattezza della descrizione: «Case bianche o nere, con strisce bianche o nere e finestre rosse e blu. Linee orizzontali del paesaggio. Canali, strade, dighe»; così è l’Olanda davvero, com’è fatta realmente. Ma allora perché ridere?
È in questo genere di dubbi che sono incappato una volta terminato Lo schiavista di Paul Beatty (Fazi, traduzione di Silvia Castoldi). Non credo ci siano tante cose più imperscrutabili della natura di una risata e Flaiano mi è corso in aiuto. Beatty, mi sono detto, dipinge gli Stati Uniti come Mondrian l’Olanda: molto seriamente, e limitandosi a descrivere con la medesima esattezza. A «far ridere», piuttosto, e prendete l’accezione nel senso a voi più congeniale, sono proprio gli Stati Uniti, così come sono realmente.
Uno stallo ermeneutico del resto era prevedibile. Il libro si dichiara (in quarta) ed è stato dichiarato «la più lacerante satira americana degli ultimi anni». Ma quando si parla di satira, lo dimostrano eventi recenti, ci si capisce ben poco, e tutti sembrano pronti a esprimersi sull’annosa questione se un’opera d’arte possa dirsi satirica o meno. Per fortuna a venirmi in soccorso è stato direttamente l’autore. Ti vedi come uno scrittore di satira? «No, per niente. Nella mia testa limiterebbe le mie possibilità, il modo in cui poter scrivere di qualcosa. Io scrivo e basta.» E come pensavo, riguardo al termine stesso: «[…] è una parola che molti buttano lì a caso. Non saprei bene come definirla». A scatola chiusa, intanto, grazie Paul.
Una questione sul realismo, capace di far vibrare il concetto stesso di satira, rimane centrale alla fine del libro. Resta un’impressione: che le risate suscitate – proporzionali al grado di immersione del lettore nella cultura americana e nera americana in particolare – si sollevino proprio su questo tipo di vuoto interpretativo. Si ride su una discrepanza, fra la realtà e le sue sovrastrutture, in cui Beatty contro ogni pronostico risulta tanto più «satirico» quanto più puntuale e verosimile. Realista è l’astrattista, mentre a mistificare è il naturalista. «Trovo che tutto sia divertente, se messo su un certo piano.» Se ne ricava, forse, un ruolo più nitido: satira non vuole dire parodiare, distorcere, ma rendere evidente ciò che avrebbe dovuto esserlo, ciò che di fronte agli occhi rimane invisibile. Una fenomenologia ironica, dunque. Se il mondo è congestionato nell’incrocio delle sue innumerevoli e macchinose interpretazioni è meglio seguire l’istinto, descrivere le cose secondo la spontaneità di quello che si ammira e si detesta, in modo tale da poterne ridere liberamente. Una spontaneità da cui scaturisce un mondo lucido e spassoso e tragico: il nudo cellulitico oltre il velo di Maya; l’imbarazzo e la messa in ridicolo dopo uno sbugiardamento; il minuscolo gingillo di Zio Sam, smutandato, che oscilla timido di fronte all’obelisco di Washington D.C. Ma attenzione: poiché sotto quella falsità, e all’ombra di quel gingillo, i neri vengono ancora ammazzati come mosche – nonostante «quel tizio» (Obama) – l’ironia fenomenologica diviene qualcosa di più. «Humor is vengeance», ci dice Beatty. L’ironia è rivalsa, e non potrebbe essere altrimenti.
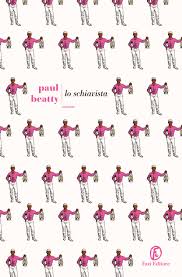
Il plot, in breve. In una terra di nessuno chiamata allusivamente Dickens, un distretto agrario ormai scomparso dalle mappe dell’immenso hinterland di Los Angeles, il figlio di un sociologo nero americano detto Bonbon, abile coltivatore di frutta e cannabis, finisce di fronte alla Corte Suprema con l’accusa di aver reintrodotto la schiavitù e la segregazione razziale. Lo schiavista si svolge allora come il racconto e il resoconto che il protagonista dedica all’intimità del lettore, una messa a nudo che espone Bonbon al suo giudizio e a quello dei giudici. «So che detto da un nero è difficile da credere, ma non ho mai rubato niente.» La rivalsa del protagonista, che allo stesso tempo lo discolpa, può essere letta come una semplice testimonianza alla luce dei fatti. Hominy, la cosa più vicina a una star del luogo (fantomatico attore nelle Simpatiche canaglie), è suo schiavo ma anche un caro amico. Marpessa, l’amore di una vita, arguta e colta e bellissima, viene riconquistata proprio grazie al nuovo corso «segregazionista». Foy Cheshire, la nemesi e l’intellettuale impegnato nella difesa della blackness, deve fare i conti con l’insperata rinascita di Dickens e dei suoi abitanti. Sono i fatti, insomma, a «scagionare» Bonbon, ed è ancora il realismo a farla da padrone, se non altro seguendo un principio di coerenza. Una scuola già segregante diviene ora più funzionale; un non-luogo dalla puzza nauseabonda (totalmente realistico, come ha avuto modo di spiegare l’autore) si fa finalmente riconoscere alla tv come quelle periferie dove soccombono i neri ammazzati dalla polizia; si scende a patti con il razzismo inossidabile dello show business. Si rendono palesi conflitti già di per sé evidenti. Nel meraviglioso monologo iniziale una donna si mette a ridere per un gorilla di nome Baracka. Per scusarsi si affretta a discolparsi: «Alcuni dei miei migliori amici sono scimmie!». Il meccanismo ironico mette qui a nudo una seconda evidenza, quel razzismo americano, viscerale e strutturale, da catechizzare finalmente per quello che è. Un denudare in cui la risata diventa assieme consolatoria e rivoltosa.
E però la grandezza di Beatty, come era accaduto a Ta-Nehisi Coates (qui), non riposa nella pura denuncia. I temi della segregazione e della schiavitù, ai quali vuole alludere il titolo italiano e che sembrano preponderanti, sottostanno a una questione leggermente al di sopra, resa esplicita dalle ultime parole del libro: «our thing», la roba nostra. Di che si tratta? L’allusione è più evidente nel metaletterario The Sellout, il titolo originale, dove «venduto» è il protagonista, surfista e amante di Kafka, poi l’autore che si permette di deridere lo schiavismo, e infine il libro stesso, destinato ironicamente al successo commerciale. Il libro di Beatty non è quindi la roba nostra, ma tutto l’opposto: il suo sputtanamento. È un esorcismo e una confessione, una sorta di «accusatio non petita» che mistifica la propria negritudine strizzando impudicamente l’occhio al lettore-compratore con un mass appeal da bianchi. Si tratta di un’avvertenza decisiva: Lo schiavista, ci suggerisce, non è un libro propriamente sulla razza, ma un libro sull’identità che parte dall’idea di un suo tradimento, un’opera che si scrolla la razza di dosso sbattendoci inevitabilmente contro. «Tutto parla di razza» infatti. E una volta individuati, masticati e mal digeriti i pregiudizi con cui veniamo bombardati, la cosa più difficile è trovare un senso proprio a quel «roba nostra» che intenderebbe circoscrivere il proprio orticello identitario. Un senso che fatica a palesarsi, lasciandoci in mano massime che hanno tutta l’aria di slogan da auto-aiuto: «stay black», rimani nero, e «be yourself», sii te stesso. Istanze con cui la coscienza di Beatty-Bonbon sembra dover fare i conti, detestandole entrambe e cercando di uscirne vivo il più pulito possibile attraverso la loro derisione e l’autoironia.
Come per Guzzanti nel suo ultimo Dov’è Mario? per Beatty il bilancio finale è spietato. Nessuno sembra scamparla, nemmeno la stessa satira, nemmeno l’autore; nel caso di Beatty solo qualche rapper, forse, e qualche grande scrittore come Céline. Sotto accusa finiscono prima di tutto la cultura e la letteratura nera, ovviamente. Almeno tre delle più monumentali cattedrali dell’emancipazione nera vengono demolite a colpi di cannone: la nascita della letteratura afro-americana, che inizia con le prime relazioni degli schiavi sopravvissuti; la sociologia, prima forma di emancipazione accademica; il movimento per i diritti civili. Al di là del meglio di quella cultura e in mezzo a queste rovine si alternano stereotipi abbracciati, l’ossessione nera per i cocomeri e l’erba, stereotipi negati, la prestanza sessuale di Bonbon, e le passioni personali dell’autore, il surf e l’amore per i classici della letteratura europea. Realtà, quindi, come le debolezze e i feticismi di ognuno. E in essa un grido d’indipendenza che passa per il travaglio di un’anti-cultura, dei luoghi comuni e del trash come della chiacchiera sociale. Un’immersione in un mare inquinato dove spicca solida l’unica boa in mezzo alle maree: se per Ta-Nehisi Coates «Tolstoj è il Tolstoj degli Zulu», per Beatty «Ognuno può scrivere quello che vuole», perché «l’appropriazione culturale va in ogni direzione». È l’emancipazione estetica il primo punto. Essere liberi vuol dire anche poter giocare con i pregiudizi e con i gusti, i propri e quelli degli altri. Il Nero Assoluto è semplicemente fottersene alla grande. Clarence Cooper, Charlie Parker, Richard Pryor, Maya Deren, Sun Ra, Mizoguchi, Frida Kalho, il Godard in bianco e nero, Cèline, Gong Li, David Hammons, Björk, e il Wu-Tang Clan in una qualunque delle sue permutazioni incappucciate.
La struttura e l’uso della lingua in The Sellout, in tal senso, spesso criticate, dipendono proprio da questo stesso saliscendi vorticoso in seno alla coscienza. Il riferimento letterario è, come capita ai più bravi, anti-letterario, fuori dai canoni. Beatty si rifugia nel meglio di quanto ha da proporre la mischia culturale post-pubblicitaria, lì dove miracolosamente sopravvive il linguaggio. Ai lati della frammentazione aneddotica che costituisce il cuore del libro vi sono due monologhi. Uno narrativo, meraviglioso e straripante all’inizio del testo, e uno ideale, di un comico nero, alla fine. Il riferimento è chiaro: l’elevazione della stand-up comedy a linguaggio letterario, la rivisitazione in chiave ironica del flusso di coscienza modulato a zapping. Un debito in cui alcuni hanno palesato una debolezza, un’insufficienza narrativa, ma che costituisce invece un’innovazione di non poco conto (anche se probabilmente the best is yet to come). È stato Chris Jackson, in una recente intervista per The Paris Review, a descrivere alla perfezione il genio di Beatty, rendendo chiara la psicosi, l’elasticità e la brillantezza della sua favella: «particular offbeat, backtracking, culture-swallowing». Una descrizione a cui è difficile aggiungere granché, così come al suo scorrere hip hop. Un fiume di parole vagamente schizoide, dai complessi e infiniti riferimenti culturali, capace di approcciare alla scomparsa di un’identità ormai allagata attraverso una scelta rapida e istintiva dei temi e dei giudizi. Una prosa riscritta ma fluida, costruita sul sovrabbondare di similitudini tipico dei neri americani, in cui l’ironia diviene fonte di rivolta tramite il principio guida dell’emancipazione del gusto. Beatty trascina così un lettore forse riluttante chiedendogli di continuo: «stammi dietro, se ci riesci». Ma correre, in definitiva, è un piacere per l’intelletto.





Aile Hekimi Malzemeleri, Diş Hekimi Malzemeleri, Veteriner Hekimi Malzemeleri ve OSGB Malzemeleri En Cazip Fiyatlarla