Tra i libri che porto appresso durante le mie solitudini di scrittura campeggia, quale opera che consulto con costanza: «Racconti raccontati due volte» (1837), calderone di racconti scritti da Nathaniel Hawthorne.
L’autore di Salem è conosciuto in Italia soprattutto per il dramma sentimentale – sullo sfondo di una America puritana sottomessa alla sua ossessione delle streghe – de La lettera scarlatta (1850); tuttavia, rispetto al romanzo, a mio avviso merita maggiore attenzione letteraria, la raccolta di novelle succitata.
Fondo le mie ragioni sul fatto che il libro è un impeccabile unicum nel territorio del racconto; e per via di una curatissima lingua (spesso rigorosa più di quella di ogni altro scrittore horror), e per via dell’originalità del perturbante insito nelle sue storie.
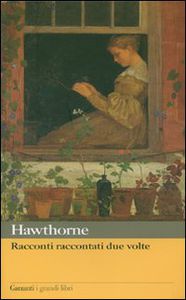
«Racconti raccontati due volte» nell’edizione Garzanti per la traduzione di Marco Papi
Così, dentro quell’isola selettiva che è la narrativa breve, Racconti raccontati due volte è fondativo di uno speciale gotico basato esclusivamente sulle suggestioni mostruose di un protestantesimo professato e insegnato demonicamente ovvero senza logica.
Fervore esagerato – che addirittura, nella raccolta, evoca il Diavolo – manifestato quasi pazzamente dai personaggi narrativi di Hawthorne, che corrispondono alla gente del Massachusetts di quel tempo.
Fra di loro il protagonista che continua a ispirarmi, riguardo alla figura del reverendo, è Hooper, chierico presente nel racconto Il velo nero del pastore, giacché ci sono in lui tre Misteri che custodisco per aiutarmi a scrivere. Il Mistero di Dio, quello del Diavolo e quello dell’Aldilà; un ultimo elemento, che però non rientra in questa trinità, perché è di origine umana, è quello di cui fa uso Hooper nella realtà fittizia del racconto: la solitudine. Una solitudine di non sola natura personale (cioè della persona) bensì di qualità esistenziale e dunque protesa al cosmo, alla domanda suprema che ci si è soliti porre.
Il reverendo è quindi condannato misteriosamente a una nullità spirituale che non trova soddisfazione nell’immanenza della preghiera, ma nel nascondimento del proprio essere in grado di non-esistere una volta che questi ha preferito coprire il volto d’un drappo oscuro. Dall’inizio alla fine.
Questo fervore della morte – di una sua estetica evidente incarnatasi nel velo – rilascia uno spavento differente rispetto ad altra narrativa gotica. La paura del Diavolo è ormai fra la pelle e la mente. Gli atti bizzarri del reverendo sono sacrifici perché con l’arrivo della morte cessi il tremore demonico.
«Ma in quel momento il pastore scorse la propria immagine nello specchio e il velo nero avvolse anche il suo spirito in quella sensazione di angoscia che aveva sopraffatto tutti gli altri. Il suo corpo fu percorso da un brivido, le labbra gli si sbiancarono, e il reverendo rovesciò sul tappeto il vino che non aveva ancora assaggiato, poi corse fuori nel buio. Anche la terra ora era coperta da un velo nero.»
Tuttavia, c’è anche un’altra figura senza nome nelle novelle hawthorniane la quale mi tormenta per la splendida invettiva che pronuncia, a metà tra la confessione letteraria di un fantasma pentito e la disperazione dell’uomo che sa di essere «cosa al più presto finita». Il racconto è La mente tormentata.
Qui, all’interno della duplice accezione dell’invettiva, l’interesse di Hawthorne per il demoniaco si ammorbidisce e pare qualificarsi come usuale e non straordinario.
Da parte del protagonista ogni elemento descrittivo, ogni presa di coscienza degli elementi romantici e funebri del vivere, sono votati certamente, nella notte del racconto, all’eternità. Ma questa è un’eternità paurosa poiché bramata e mai definita specificamente. Quasta indefinibilità si percepisce e aleggia soprattutto perché la voce narrante è succube di un’insicurezza quasi sonnambolica. Per tale ragione il regime linguistico appare visionario e filosofico nonostante sia lo stile incorniciato secondo un rigore che non dovrebbe lasciare spazio all’allucinazione.
Si direbbe che nella novella Hawthorne riese a vedere e a scrivere dell’Aldilà con assurda precisione linguistica.
«Trasalendo involontariamente, riprendiamo coscienza e ci troviamo quasi svegli, mentre tracciamo un confuso parallelo tra la vita umana e l’ora che è appena trascorsa. In ambedue i casi, si esce da un mistero per passare attraverso vicissitudini che si possono controllare solo in parte ed essere poi trasportati verso un altro mistero. Si odono poi i rintocchi di una campana lontana, sempre più fievoli mentre si sprofonda di nuovo nella solitudine del sonno. È come il rintocco funebre di una morte temporanea. Lo spirito si diparte e vaga liberamente tra gli abitanti di un mondo indistinto, che guardano strane cose, ma senza meraviglia o sgomento. Così sereno sarà forse l’ultimo cambiamento, e così placido, come tra cose ben note, sarà l’ingresso dell’anima nella sua dimora eterna.»
Per concludere il mio breve viaggio gotico, in Racconti raccontati due volte c’è spazio per una novella che mi ricorda il folclore satanico della Louisiana presente nella serie tv HBO, True Detective. Cioè quella ritualità rurale in cui i sacerdoti delle messe campestri (nonché i suoi partecipanti), indossano maschere animalesche in volto, e corna di cervo in testa.
«Si trovano interessanti spunti per un romanzo filosofico nella curiosa storia del primo insediamento di Mount Wollaston, detto Mont’Allegro. Nel breve racconto qui abbozzato, i fatti, quali sono registrati nelle ponderose pagine dei nostri annalisti del New England, si sono elaborati quasi spontaneamente in una sorta di allegoria. Le mascherate, le pantomime e le feste descritte nel testo sono conformi a quelle in uso a quel tempo.»
Il racconto ha il titolo di L’Albero di Maggio di Mont’Allegro.
Esso narra di un gruppo di coloni che venerano – seguendo una sorta di macabra festosità cerimoniale – un albero quale stendardo – esso è Dio o Diavolo? – della loro comunità, quella di Mont’Allegro.
In una specie di lupercalia azzardata, le preghiere dei fedeli all’albero – capeggiati da un sacerdote, l’Uomo dei boschi – via via assumono una oscura forza pagana qualificata tale dal «puritano dei puritani», Endicott. Quest’ultimo, che decreterà la distruzione dell’albero e dei suoi baccanti, sembra esercitare un ruolo purificatore simile a quello di Rust Cohle, il detective visionario e filosofico di True Detective. Entrambi eliminano gli idoli demonici – e allontanano i loro cerimonieri – perché trionfi una giustizia religiosa (la loro) del tutto carica di grazia.
Endicott e Cohle sono però servi di «un’oscurità illuminata» che entrambi qualificano diversamente.
Per l’uno è Dio, per l’altro è il Bene.
«Non potevano essere fauni e ninfe che, scacciati dai loro classici boschetti e dimore delle antiche leggende, avevano cercato rifugio, come tutti i perseguitati, nei freschi bosci d’Occidente, perché quelle lì intorno erano creature gotiche […] Sulle spalle di un aggraziato giovane si ergevano la testa e le corna ramificate di un cervo; un altro, umano in ogni altro aspetto, aveva il truce volto di un lupo; un terzo, anch’esso colo tronco e le gambe di un mortale, mostrava la barba e le corna di un venerabile caprone.»




I like the helpful information you provide in your articles.
I will bookmark your weblog and check again here frequently.
I am quite certain I’ll learn many new stuff right here! Good luck for the next!
Great article.
Hi there! I simply wish to offer you a big thumbs up for your excellent info you have right here on this post.
I’ll be returning to your website for more soon.
Recensione davvero densa e intensa. La raccolta non può che sembrare molto interessante 🙂 la leggerò.
Grazie!