Il titolo italiano, Elegia americana (traduzione di Roberto Merlini, Garzanti), trasmuta il memoir di J.D. Vance non in un’autobiografia di un hillbilly, come nella versione originale, ma nella confessione di un americano e ‒ si sarebbe tentati dal dire ‒ dell’americano, non si sa quanto medio ma si può immaginare quanto «ideale». Gli hillbilly o redneck o white trash sono i bifolchi, i buzzurri: quegli americani di origine scozzese-irlandese della regione montagnosa e rurale degli Appalachi, noti per essere burberi e piuttosto recalcitranti ai cambiamenti, per menare le mani e per una religiosità spesso esasperata, per l’alcolismo, le droghe e le case mobili. Ecco, J.D. Vance è un hillbilly che ce l’ha fatta.
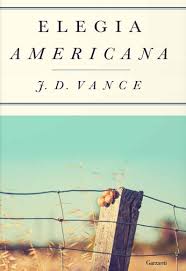
Nato in Kentucky, da una madre che alla stesura del libro sarebbe arrivata al quinto marito e a una tossicodipendenza da eroina e da un padre che dopo averlo abbandonato si sarebbe convenientemente rivelato un fondamentalista evangelico antievoluzionista, Vance è stato allevato dagli adorati nonni in Ohio. A Middletown per l’esattezza, un nome di una medietà quasi provvidenziale per la narrazione del nostro. Dopo aver superato quasi indenne gli innumerevoli ostacoli di questa famiglia scalcinata e della povertà connessa, Vance si arruola nei marines ‒ che gli dànno una bella sistemata, perché prima si faceva le canne ‒, va in Iraq in mimetica a regalare cancelleria ai ragazzini locali, dopodiché si iscrive a Legge alla Ohio State University e si specializza a Yale. È il primo della sua famiglia a uscire da un ateneo della Ivy League. E quindi ci racconta come ha fatto.
In generale, dubito sempre delle autobiografie di chi ha appena trent’anni. È pieno di calciatori che prima di finire la carriera ne hanno almeno tre all’attivo. Ma in questo caso, oltre al memoir di un trentenne, ci troviamo di fronte a una specie di «Che cos’è la povertà for dummies», un bestseller che ha fruttato all’autore un riconoscimento niente male in patria, dov’è ospite fisso in tv, e all’estero, dove ha vaticinato sul Guardian e su Repubblica, per dire.
Sì, in Ohio e Kentucky, i due stati che interessano il libro di Vance, Trump ha vinto e, almeno nel secondo caso, con un buon margine. L’Ohio un tempo era stato una roccaforte democratica. Adesso, il sottoproletariato bianco coi denti marci per le bevande zuccherate e rimasto senza lavoro per la chiusura delle acciaierie vota l’autolesionismo. Questo implica che Vance abbia delle cose da dirci sul perché un multimiliardario fraudolento sia stato visto come una risposta contro le élite da molti bifolchi senza più lavoro ma con un inesauribile penchant per la violenza domestica.
Il libro di Vance è apertamente politico e di destra. A un racconto biografico piuttosto ridondante e faticoso si sommano le classiche ricette della destra conservatrice: l’elogio sperticato di una famiglia salda, monogama e cristiana e la conseguente e strisciante riprovazione per divorzio e costumi sessualmente liberi; la retorica religiosa corroborata da studi scientifici farlocchi che dimostrerebbero l’efficacia della fede come collante sociale; la simpatica e folcloristica presenza di armi da fuoco in casa; la classica conversione a U e il reborn che abbandona spinelli e cd dei Black Sabbath per seguire i precetti evangelici; l’insistenza sui valori individuali rispetto a quelli sociali con tutto il corollario di frasette motivazionali e baggianate da manuale di auto-aiuto (col duro lavoro si arriva in ogni dove ecc.); la drammatica e scellerata apologia della vita militare, dei marines, del patriottismo e della War on Terror di W. Shakerate il tutto con qualche romanzo di Ayn Rand et voilà, il piatto è servito.
Perché gli un tempo pii abitanti della Bible Belt se la passano così male? Di sicuro è colpa dell’assistenzialismo che ha trasformato la vicina di J.D. in una dissoluta welfare queen, dedita a ogni tipo di sconcezza e vizi, nonché agguerritissima macchina sfornafigli, il tutto pagato da noi contribuenti che col sudore della fronte e via dicendo. Ma è anche colpa della fine della vecchia probità borghese:
Compriamo televisori giganteschi e iPad. I nostri figli indossano capi di lusso grazie alle carte di credito che applicano interessi stratosferici e ai prestiti garantiti dallo stipendio. Compriamo case di cui non abbiamo bisogno, le rifinanziamo per poter spendere altri soldi e andiamo in fallimento, lasciandole spesso piene di robaccia. Non sappiamo cosa sia la parsimonia. Spendiamo per far finta di appartenere alla classe superiore. E alla resa dei conti ‒ quando incombe il fallimento o quando un familiare viene a tirarci fuori dai guai ‒ non rimane più nulla. Nulla per pagare le rette universitarie dei ragazzi, nessun investimento per accrescere il nostro patrimonio, nessun risparmio nell’eventualità di perdere il lavoro. Sappiamo benissimo che non dovremmo spendere e spandere in questo modo. A volte ci prenderemmo a pugni per questo, ma lo facciamo lo stesso.
Le nostre case sono in preda al caos. Gridiamo e ci insultiamo come se fossimo spettatori di una partita di football. Almeno un membro della famiglia assume stupefacenti ‒ a volte il padre, a volte la madre, a volte tutti e due. Nei momenti più difficili, ci prendiamo a cazzotti davanti al resto della famiglia, inclusi i bambini piccoli. Il più delle volte, i vicini sentono tutto e, quando esageriamo, chiamano la polizia per mettere fine al pestaggio. I nostri figli sono dati in affido ma non ci restano mai a lungo. Ci scusiamo con loro. Pensano che siamo veramente dispiaciuti, e lo siamo. Ma poi riprendiamo ad agire nello stesso modo.
Da ragazzi non studiamo, e quando siamo genitori non facciamo studiare i nostri figli, che perciò vanno male a scuola. Potremmo prendercela con loro, ma non gli diamo mai gli strumenti ‒ primo tra tutti la pace domestica ‒ per avere successo. Anche i migliori e i più brillanti andranno all’università dietro l’angolo, se sopravviveranno a quel teatro di guerra che è casa loro. […]
Al momento di cercare un lavoro decidiamo di non fare niente. A volte lo troviamo, ma non dura. Ci licenziano perché arriviamo sempre in ritardo, perché rubiamo la merce e la vendiamo su eBay, perché un cliente si lamenta del nostro fiato che puzza di alcol, o perché facciamo cinque pause «fisiologiche» di mezz’ora per turno di lavoro. Ci riempiamo la bocca con il valore del lavoro ma diciamo a noi stessi che non lavoriamo perché siamo vittime di un’ingiustizia: Obama ha chiuso le miniere di carbone, oppure tutti i posti di lavoro sono andati ai cinesi. Sono bugie che ci raccontiamo per superare la dissonanza cognitiva, l’evidente incoerenza tra il mondo che vediamo e i valori che predichiamo.
Ovvio, il problema della regione, che si è vista portare via la principale fonte di ricchezza ‒ l’industria mineraria ‒ per manifesto anacronismo, non è mica la povertà. La povertà, se remota e superata in una battaglia individuale fatta di ostacoli da scavalcare tipo «come comportarsi a tavola quando c’è un set di nove posate», è sempre bella e costantemente idealizzata nelle pieghe del libro. Il problema è che la gente degli Appalachi ha perso la sua «religione», qualsiasi cosa essa significhi. E l’equiparazione tra i vizi caratteriali individuali e collettivi e la povertà, che non è esattamente una novità per l’etica protestante, sottende tutta la tirata randiana di Vance.
Abbiamo cominciato a provare sfiducia nei confronti di quasi tutti gli altri membri della classe operaia. Tiravamo avanti a fatica, ma ci arrangiavamo lo stesso, sgobbavamo e speravamo in una vita migliore. Ma una grossa minoranza si accontentava di vivere a spese della collettività. Ogni due settimane ricevevo un piccolo assegno e prendevo nota della ritenuta fiscale. Altrettanto spesso, la nostra vicina tossicodipendente acquistava bistecche con l’osso, che io non potevo permettermi ma che lo zio Sam mi costringeva ad acquistare per qualcun altro. La pensavo così quando avevo diciassette anni, e anche se oggi sono meno arrabbiato di allora, cominciavo a capire che le politiche del «partito dei lavoratori» tanto caro alla nonna ‒ il Partito democratico ‒ non erano poi così meritorie.
I politologi hanno usato milioni di parole nel tentativo di spiegare come mai gli Appalachi e il Sud siano passati dal Partito democratico al Partito repubblicano in meno di una generazione. Alcuni danno la colpa ai rapporti razziali e all’appoggio fornito dai democratici al movimento per i diritti civili. Altri citano la fede e la presa del conservatorismo sociale sugli evangelici di quella regione. La spiegazione sta più probabilmente nel fatto che molti bianchi della classe operaia((È piuttosto curiosa l’omogeneità culturale e razziale di chi si è reso conto che le politiche assistenzialiste dei democratici non funzionavano e ha iniziato a votare repubblicano. Siamo proprio sicuri che razzismo e diritti civili non c’entrino nulla? ndr)) hanno visto quello che ho visto io quando lavoravo da Dillman’s. Negli anni Settanta, il proletariato bianco cominciò a guardare con fiducia a Richard Nixon perché aveva la sensazione che il governo «pagasse i disoccupati per fare nulla! Questa gente si fa beffe della nostra società e noi siamo dei grandissimi lavoratori, che vengono presi per i fondelli perché vanno a lavorare tutti i giorni.
Insomma, i poveri un po’ se la cercano la povertà, non è mica colpa del sistema se la povertà esiste, del resto guardate il nostro paffutello J.D., lui ce l’ha fatta. Perché? Perché non ha fatto debiti comprando televisori da millemila pollici e cellulari costosissimi, e dunque implicitamente uno stile di vita che non si poteva permettere ma era lì ovunque a rappresentare plasticamente il meglio della vita. Vance ha incarnato benissimo i valori dell’austerity facendo la formichina, non figliando da adolescente e preferendo la carità e la beneficienza (da praticare e ricevere) ai golosi assegni del welfare. Non bisogna avere sfiducia nel sistema che ha trascinato il mondo intero nella crisi dei subprime del 2006 e anzi, prendersela con il governo, la finanza, il presidente di turno o le élite diminuisce solamente le possibilità di ascesa di chi ha la disgrazia di estrarre la pagliuzza più corta nella lotteria della vita.

Tra parentesi, per qualcuno che ce l’ha tanto con il welfare, il buon Vance ha usufruito di un sacco di stato sociale per arrivare dov’è arrivato. Per esempio, senza il G.I. Bill, un programma governativo che serve tra le altre cose a pagare gli studi ai reduci, non sarebbe mai riuscito a fare l’università.
Ma secondo Vance, il problema è culturale, non economico. E in questo manifestamente confonde ‒ proprio al contrario di quello che crede ‒ la causa con l’effetto. Il risentimento dei suoi ex conterranei (oggi lui fa il venture capitalist a San Francisco e prossimamente su questi schermi, di sicuro, paleserà le sue ambizioni politiche), il fatto che a un disagio sociale diffuso corrispondano un’incidenza maggiore di alcolismo, delinquenza e abuso di stupefacenti, non vanno spiegati certo con le innate radici culturali, l’insularità e il pessimismo atavico di gente di montagna poco abituata a mescolarsi con gli sconosciuti e ad accettare le sfide della modernità. Ma forse – più prosaicamente – col fatto che territori già storicamente poveri si sono impoveriti ulteriormente con la scomparsa del manifatturiero.
Il razzismo, salvo qualche periodo circostanziale e chiaramente atto a rassicurare i facilmente impressionabili, è il grande assente di questo memoir. L’autore ci assicura di essere conscio del fatto che la sua famiglia e il suo background abbiano pregiudizi razzisti, ma poi quando passa a spiegarci i motivi per i quali Obama viene visto come il fumo negli occhi da quelle parti ‒ mentre invece Bill Clinton no ‒ a sorpresa il fatto che sia un nero gli sfugge di mente. È assai più rilevante che faccia parte delle élite, che abbia un accento neutro, vesta bene, sia un padre impeccabile e abbia studiato nelle migliori università. Inavvertitamente, Vance fa centro quando dice che «Barack Obama fa risaltare le nostre insicurezze più profonde».
I neri, negli sbrigativi paragrafi in cui Vance ne parla, sono visti come «vicini» agli hillbilly, quantomeno demograficamente, ma il tema forte del libro è piuttosto chiaro: che fine ha fatto la working class bianca che affollava le chiese e teneva in piedi l’industria americana? E se volete, radicalizzando la sua bolsissima e annacquata proposta, che fine ha fatto l’America?
C’è bisogno che io dica Make America Great Again?

In Inghilterra, qualche anno fa uscì un libro assai più onesto e seminale intitolato Chavs. The Demonization of the Working Class. In copertina aveva il classico berretto a scacchi tartan Burberry del coatto british; i chav difatti sono l’equivalente degli zarri o dei truzzi nostrani: gusti «volgari» e costosi associati a un reddito mediobasso e in via di impoverimento. Fatta salva la variante geografica, il soggetto dei due libri è più o meno lo stesso, l’approccio radicalmente diverso. Owen Jones, l’autore, dimostrava come anni di thatcherismo, con la sua implacabile retorica sugli scrocconi di benefits, e la gentrificazione di zone un tempo destinate ai lavoratori avevano trasformato e ghettizzato la working class britannica ridicolizzandone e stigmatizzandone tic, gusti, atteggiamenti e stili di vita. Una campagna di demonizzazione incessante condotta dai politici e dai media e poi inevitabilmente raccolta e fatta propria nel solito sussulto di masochismo da chi invece ne era il bersaglio, i lavoratori. Diseguaglianze e odio di classe che sfoceranno poi nelle riots a Londra, a Birmingham e a Manchester dell’estate 2010.
Allo stesso modo di Thatcher e dei suoi innumerevoli e sbiaditi epigoni, Vance si fa portavoce non si sa quanto volontario o meno di un odio di classe divisivo e paternalistico e di un tentativo di marginalizzazione che è l’atteggiamento tipico del ceto medio nei confronti di chi rimane indietro. Un modello che è da anni portato avanti e rappresentato dai repubblicani e dai loro media – Fox News in testa – contro sì i benefits scroungers ma implicitamente anche contro tutti i white trash di cui si fa campione, che dalla destra di ogni nazione vengono usati e blanditi solo come serbatoio elettorale, e che a sinistra si fa sempre più fatica a capire, a rappresentare o anche solo a entrarci in contatto visto che non si tratta degli ultimi, ma dei penultimi; peraltro ben difficili da idealizzare e amare.
Si è detto che se vogliamo capire gli Stati Uniti di Trump, l’America profonda, bisogna leggere Elegia americana. È vero. Ma per capire gli Stati Uniti di Trump e il suo retroterra bianco, ignorante e imbevuto delle scorie tossiche del Sogno americano forse basterebbe riguardarsi Le colline hanno gli occhi o Society o La casa del diavolo e magari Non aprite quella porta. O anche solo leggere Toni Morrison, un’autrice cresciuta in Ohio come Vance e che non potrebbe avere un’esperienza di vita più radicalmente differente, o un racconto come Uomo bianco di James Baldwin, oppure Breece D’J Pancake. Trenta e passa anni fa usciva Trilobiti e parlava profeticamente di chi non riesce né a fuggire né a rimanere nelle angustissime cittadine del West Virginia. Posti inospitali, in cui anche gli ultimi lavori malpagati e insicuri sono spariti con la chiusura delle miniere. I protagonisti di Trilobiti sono gli stessi che animano le pagine di Elegia americana e con tutta probabilità, se sono ancora vivi e alle prese con la Mountain Dew Mouth, oggi votano Trump.




22 Comments