È stato un buon anno per la montagna in letteratura tra Cognetti che vince lo Strega e Corona (l’altro) che insegue dei vandali non barbari cercando di accettarli con l’accetta. Uno pensa di aver pagato l’annuale tributo di sangue a valli e ghiacci e brume quando ecco che ti arriva Preghiera d’acciaio, il libro di Angela Bubba, che si apre proprio con un rito di passaggio in un bosco di montagna.
Zio Ben, un lupo solitario dagli «zigomi logici e i luccicanti occhi egiziani», dialoga a colpi di silenzi sapienziali con la nipote ventenne, che ha portato su insistenza di lei a sparare per la prima volta. Una lezione di vita che ben presto si tramuta in una lezione di scrittura: «l’esitazione è parte dell’azione» e dunque mai spaventarsi di fronte alla pagina bianca, oppure «il risultato non vale niente se non sai come raggiungerlo, sono gli strumenti a essere inestimabili»; e qui verrebbe da citare un classico dei Motörhead The Chase Is Better Than the Catch, è la caccia a essere più importante della preda, la scrittura più del libro come oggetto finale. Ma fioccano massime anche sullo stile: nella vita come nella scrittura conseguirlo non è facile né è facile trattenerlo, si tratta di adattamento e spirito di sopravvivenza, non di una scelta estetica bensì della sola cosa che ci permette di stare al mondo.
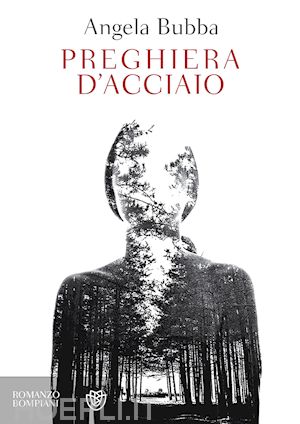
Sono tutte riflessioni di carattere presocratico e a voler essere precisi eraclitee, capaci cioè di abbracciare tutto e il suo contrario in un viluppo inestricabile, ad animare un dialogo continuo, spungiforme e mobile come in un testo di Platone in cui i personaggi cercano l’archè, meditando e sentenziando, confondendo e tacendo. Un dialogo incessante fatto di domande sterminate e risposte lapidarie volto a stabilire un principio: cos’è più giusto, perdonare o vendicare? In effetti Preghiera d’acciaio è un romanzo intriso di ellenismo, come Alessandro Magno deve andarsi a procacciare il suo regno perché l’Europa gli sta stretta, così la nipote deve tracciare un nuovo sentiero per sé e per gli altri, che al massimo ne possono ricalcare le orme. La protagonista – innominata, potrebbe essere chiunque fra noi – è un’estranea che si guarda dentro, «come Marco Aurelio che si rivolgeva a se stesso parlando al vocativo».
Zio Ben (sta per Beniamino qualora ve lo steste chiedendo), talvolta assume pose à la Splinter (penso a quando procede dispensando aforismi, come: «Devi imparare a trattenere energia») e ci sono delle scene sopra le righe (per esempio quando, dentro l’abitacolo di quella che per tutto il tempo mi sono immaginato essere una Panda 4×4, lo zio mima le strida di uno sparviero e l’uccello prontamente si palesa sopra la macchina), ma il dialogo estenuato maestra-allieva in cui i ruoli raramente si capovolgono regge, e anzi è forse la parte migliore di questo strano romanzo, che ha in sé anche altre tecniche: l’epistolario, il manoscritto ritrovato.
Da questo colloquio vasto eppure ossuto, emerge che non c’è innocenza – ma bisogna pur sempre lanciarsi alla sua ricerca ineffabile – e sebbene tutti i traumi siano uguali fra loro sono pochi quelli che sanno metterli a frutto. Come suggerisce la splendida immagine tesa a rappresentare il libro in copertina, il bosco è dentro ognuno di noi e come un’ombra si annida anche nel cuore di questo romanzo. Un bosco abbastanza grande «perché non si riesca più a trovare il modo di uscirne» per citare Stephen Graham Jones. Chi legge e chi scrive, come vuole l’abusato aforisma nietzschiano, dovrà sondare gli abissi dentro di sé e sviscerare sulla pagina e non solo il dolore che avrà incontrato.
Le insidie di una scrittura troppo immaginifica e che procede per la forza propulsiva delle sue metafore, come pure quelle tutte speciali irte di retorica della montagna e del bosco sono perlopiù schivate grazie a un romanzo progettualmente incentrato su cosa significhi indagare i recessi della nostra psiche e riversarli su pagina.
Ma se qualche lettore si attendesse indicibili rivolgimenti di trama e agnizioni incredibili farebbe bene a guardare altrove; del resto è tutto dichiarato fin dal principio: il romanzo che stava scrivendo la protagonista era «tutto trama» e proprio per questo andava disossato e scarnificato. La trama è presto detta: durante una battuta di caccia in montagna la protagonista chiede il fucile allo zio, un uomo dai trascorsi cupi, e per la regola di Čechov sappiamo già che quell’arma farà fuoco. Ma contro chi? C’è un dottore, un uomo che ha fatto del male a un gruppo di bambini che, ora cresciuti, hanno organizzato una vendetta collettiva; ma la trama – come detto più volte nel romanzo – conta poco, il libro è irriducibile e più complesso di questo «riassuntino stiracchiato».
Ogni libro, se stiamo a questo perlomeno, è «un lutto» perché per vocazione vi si deve dedicare ogni risorsa e sacrificare tutto. «Scrivere un libro vuol dire uccidere qualcuno?» «Qualcuno o se stessi, o entrambi. Muore in ogni caso qualcosa?» Si tratta dunque di una vendetta a mezzo stampa? Un omicidio da consumarsi dentro le pieghe di un libro o il libro stesso è per sua intima natura un omicidio?
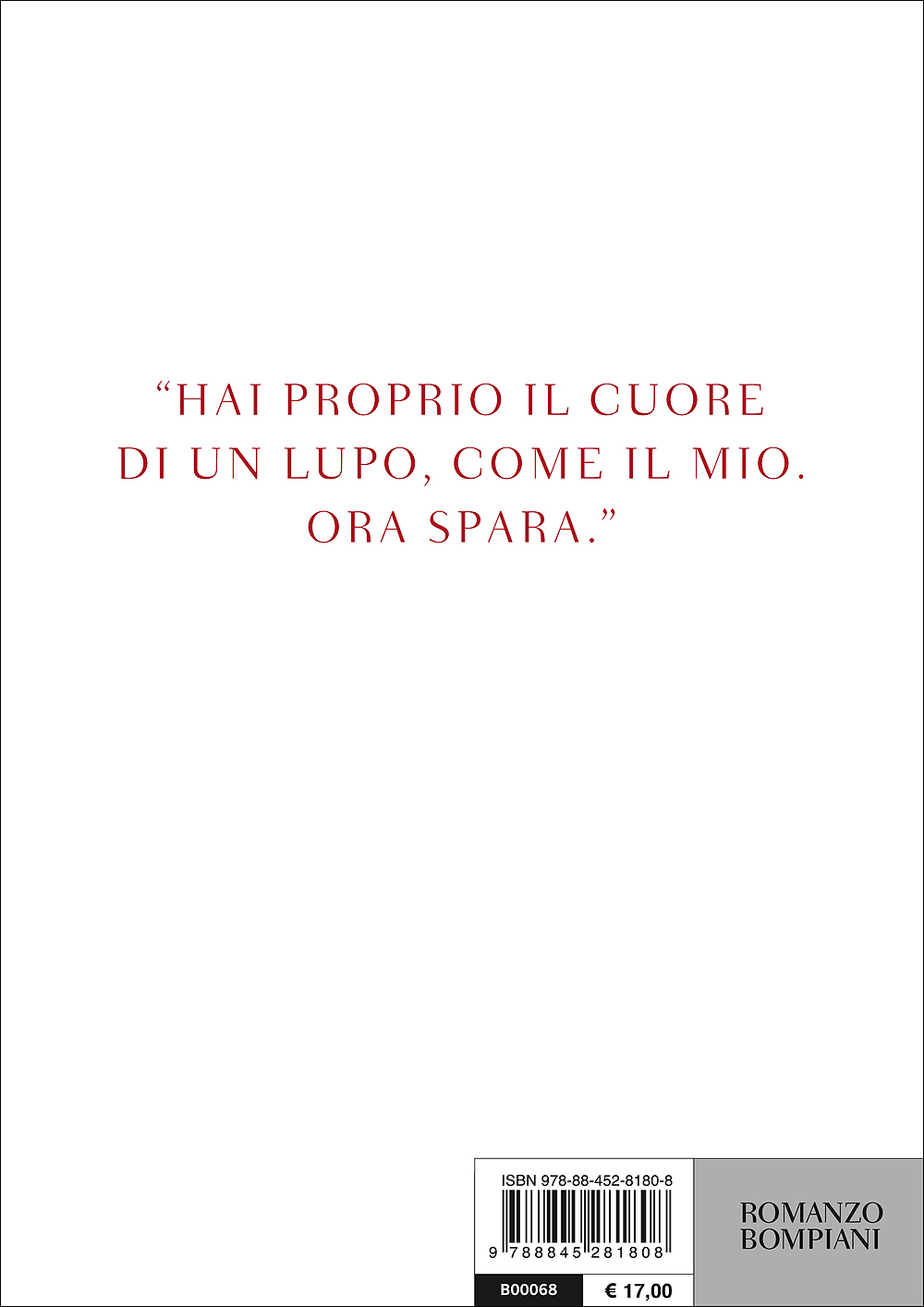
Bubba ha una penna dotata per sondare gli umori dei paesaggi e per scavare i volti dei personaggi e così guardiamo «le faglie del suo mento», e le sopracciglia diventano «manubri», un cielo è «un grande scialle lavanda bucherellato dagli stormi» o quello «aragosta del tramonto», gli avvallamenti «sembravano sculture di cartapesta», la luna è «tonda e lievissima come un’ostia».
Di similitudine in similitudine, come in un romanzo di Saul Bellow o per i più incolti anche nel Mariachi di Rodriguez, la protagonista serba il suo prezioso fucile dall’unica e salvifica pallottola in una custodia di sax; un fucile che è «una scheggia di meteorite piombata sul mio letto. Ci osserviamo senza far rumore, ci scambiamo promesse». Un oggetto che non ha il potere di intimorirla e che parla la sua stessa lingua.
A proposito di violenza e similitudini, come in un film di Tarantino, questa è tutta nei dialoghi e in come vi vengono dosate le parole, spesso acuminate, con una ricorsività lacerante che solo alla fine romperà gli indugi e tracimerà in violenza di fatto. Sono scambi alle volte piuttosto verbosi: parlerebbero così i bambini glaciali del Tempo materiale se avessero letto Acqua viva di Clarice Lispector e diciamo che il coefficiente di animali molestati nel libro si avvicina molto a quello di Vasta.
La protagonista è una sognatrice: una che ha in spregio gli psicologi (spassoso il passaggio in cui si parla male della coinquilina psicologa) e difficilmente sarà felice perché ha in sé il germoglio della speranza, che gli animali felici non hanno per natura. Eppure si alternano stati di anaffettività completa e risolta – il cuore di lupo più volte evocato – alla riflessione amara sul fatto che non potendo amare non potrà neppure mai odiare. I sogni – e qui ci starebbe una bella moratoria per evitare che i novelli Schnitzler e Freud ce li raccontino nei libri, basta vi prego è la sublimazione della noia – sono una preghiera d’acciaio, lo scrittore è un cacciatore e la sua è una pratica dell’insicurezza da affrontare con la canna del fucile spianata.




28 Comments